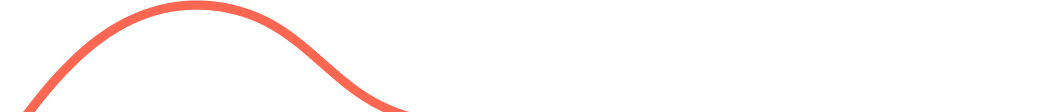Intero numero disponibile qui.
Alfonso Maurizio Iacono, Università di Pisa
E-mail: alfonso.iacono@unipi.it
doi: 10.14672/vds20231ip3
(https://doi.org/10.14672/vds20231ip3)
Abstract
Il senso della memoria e della storia tende a perdersi. Il dominio comunicativo dei mass media e dei social spinge a trasformare la semplificazione in una realtà assoluta. Accade come per i prigionieri della caverna di Platone, i quali, vedendo di fronte a loro le ombre che si muovono sulla parete, pensano che siano l’unica realtà da conoscere.
Per Primo Levi il desiderio di semplificazione, il fatto cioè che noi abbiamo comunque bisogno di filtrare il rumore che ci perviene dal mondo e di ordinarlo in suoni che abbiano un senso e un significato, si può giustificare, perché la nostra conoscenza è limitata, ma non la semplificazione, il pretendere cioè che la nostra conoscenza corrisponda ontologicamente al mondo. Tale pretesa infatti risponde molto di più a una strategia di rassicurazione che a una strategia della conoscenza. Noi viviamo in un mondo ansiogeno, e cerchiamo delle rassicurazioni. Non ci sarebbe niente di male in questo bisogno umanissimo, se non fosse però che esso tende a trasformarsi in un mezzo di riproduzione del dominio e della sudditanza.
La rassicurazione spinge verso la condizione di minorità, che diviene luogo di sicurezza a tutto danno dell’autonomia.
Keywords: semplificazione, memoria, confine, naturalizzazione, zona grigia
The sense of memory and history tends to be lost. The communicative dominance of mass media and social drives to turn simplification into absolute reality. It happens as with the prisoners in Plato’s cave, who, seeing the shadows moving on the wall before them, think that they are the only reality to be known.
For Primo Levi, the desire for simplification, that is, the fact that we nevertheless need to filter the noise that comes to us from the world and to order it into sounds that have meaning and significance, can be justified because our knowledge is limited, but not the simplification, that is, the claim that our knowledge corresponds ontologically to the world. Such a claim responds much more to a strategy of reassurance than a strategy of learning to reach an understanding (Knowledge). We live in an anxiogenic world, and we seek relief. There would be nothing wrong with this human need, except that it tends to turn into a means of reproducing domination and subjection.
Reassurance pushes toward the condition of the minority, which becomes a place of security to the detriment of autonomy.
Keywords: simplification, memory, border, naturalization, grey area
Il cane e il globulo bianco
Quando si osserva un cane che cerca di raggiungere il padrone – scrive il biologo Henri Atlan – e che è in grado di svolgere operazioni estremamente complicate – salire in auto, aprire una porta, ecc. – noi descriviamo questi fenomeni come comportamenti chiaramente finalizzati, come se il cane avesse un’intenzione sin dall’inizio (quella di raggiungere il padrone) e come se in seguito tutto il suo comportamento fosse diretto da questa intenzione […] Attribuiamo al cane un comportamento di cui abbiamo un’esperienza interna: l’esperienza dei nostri comportamenti finalizzati e intenzionali allorché vogliamo raggiungere consapevolmente un fine[1].
Immaginiamo ora di osservare, continua Atlan, un comportamento che sia in tutto simile al comportamento del cane, salvo per il fatto che lo si osserva non al livello del cane ma a quello di una singola cellula, ad esempio un globulo bianco del sangue che viene osservato al microscopio e la cui funzione è quella di fagocitare corpi estranei, batteri o cellule morte che devono essere eliminate dall’organismo. Anche in questo caso vediamo una cellula che si dirige verso la sua preda, e che all’occorrenza aggira ostacoli, cambia di forma per intrufolarsi in passaggi difficili, ecc. “Eppure non attribuiamo alla cellula un’intenzione; al contrario cerchiamo, e spesso troviamo, un meccanismo causale fisico-chimico in grado di spiegare il fenomeno”[2].
La domanda che si pone Atlan è: dove si colloca il confine nella scala degli esseri? Dov’è che comincia il terreno privilegiato della spiegazione chimico-fisica e dov’è che invece comincia quello della intenzionalità? “Fra i comportamenti delle singole cellule e quelli del cane alziamo in un certo punto una barriera che ci impedisce di parlare di intenzioni per le cellule ma non per il cane. Ma dove è situata questa barriera? – continua Atlan – E da quale parte della barriera porremo un’alga, un mollusco, una rana? Descriveremo i loro comportamenti in termini puramente meccanici, come nel caso della singola cellula, oppure in termini intenzionali, come nel caso del cane?”[3]
Rispondere alla questione posta da Atlan non è facile: se si presume che esista da qualche parte nella natura, nascosto, un punto o un luogo indipendente da noi, che ci permetta di tracciare una linea di divisione e, conseguentemente, di spiegarci la differenza tra i comportamenti degli esseri viventi, dove sarebbe collocato il confine? In realtà a me pare persuasivo quello che dice Atlan: siamo noi, o meglio i nostri codici culturali, a tracciare il confine. “Noi poniamo la barriera dell’intenzionalità in un punto particolare non certo per ragioni oggettive, che sarebbero inerenti alla natura delle cose e indipendenti quindi dal contesto in cui le osserviamo”[4]
La “zona grigia” è un confine
La storia del cane e del globulo bianco ha molto a che fare con il fatto che i confini, come ogni geografo sa bene, sono artificiali: questo non vuol dire che non ci siano contenuti o elementi naturali, ma che lo stabilire le differenze o le discriminanti è un artificio, un risultato della cultura e del sapere. Non si danno condizioni naturali. La naturalizzazione è sempre un processo che noi attiviamo per toglierci il peso delle scelte che facciamo.
La cornice di un quadro è un confine che permette di cogliere la differenza. Essa offre significato, crea contesto, permette di distinguere e focalizzare quel ritaglio del mondo che il pittore opera nel quadro differenziandolo dal resto dello spazio circostante. La cornice, in quanto è un confine, avverte lo spettatore del fatto che quel che contiene e delimita al suo interno è uno specifico mondo di significati; in quanto è un contesto, dà senso a quel mondo. L’essere avvertiti sul confine, sulla cornice, sul contesto è ciò che ci rende consapevoli e liberi. Tale avvertimento, infatti, ci permette di evitare quel che spesso ci accade quando ci avventuriamo nella conoscenza, nella interpretazione e nel giudizio sulle cose del mondo, di pensare cioè che le nostre idee e le nostre azioni non appartengano a noi uomini, esseri storici e sociali, ma alle cose. Quando questo accade, quando cioè attribuiamo alle cose quelli che sono i risultati delle nostre azioni, non ci accorgiamo che le semplificazioni attraverso cui tentiamo di spiegare i fenomeni della storia e della natura non appartengono alla intrinseca natura delle cose, ma al nostro modo di concepire come naturale quella riduzione della complessità attraverso cui cerchiamo di conoscere gli oggetti e gli eventi. Come osservava Giambattista Vico, noi possiamo conoscere la storia perché la facciamo.
La storia e la semplificazione
Primo Levi inizia il secondo capitolo de I sommersi e i salvati con alcune considerazioni sul perché sia necessario non semplificare. Egli scrive: “tendiamo a semplificare anche la storia, ma non sempre lo schema entro cui si ordinano i fatti è individuabile in modo univoco, e può dunque accadere che storici diversi comprendano e costruiscano la storia in modi fra loro incompatibili”[5]. Questo vuol dire solo che ogni interpretazione rientra in uno schema e ritaglia un mondo che non è complementare, né si completa con gli schemi e i mondi delle altre interpretazioni.
Da qui il senso epistemologico e terapeutico del semplificare: “Ciò che comunemente intendiamo per ‘comprendere’ coincide con ‘semplificare’: senza una profonda semplificazione, il mondo intorno a noi sarebbe un groviglio infinito e indefinito, che sfiderebbe la nostra capacità di orientarci e di decidere le nostre azioni. Siamo insomma costretti a ridurre il conoscibile a schema: a questo scopo tendono i mirabili strumenti che ci siamo costruiti nel corso dell’evoluzione e che sono specifici del genere umano, il linguaggio e il pensiero concettuale”[6]. Richiamandomi ancora a Vico, potrei dire che gli uomini, sono riusciti a trasformare i loro limiti in vantaggio, costruendo le astrazioni concettuali[7].
L’avvertenza di Primo Levi, il quale ci mette in guardia contro la semplificazione nella storia, assume una maggiore attualità oggi di fronte a una tendenza molto potente alla semplificazione legata anche alla spettacolarizzazione degli eventi. Un evento politico, culturale, naturale, scientifico somiglia sempre più a un evento sportivo. Inoltre, tende perdersi il senso della memoria e della storia. Il dominio comunicativo dei mass media e dei social tende a trasformare la semplificazione in una realtà assoluta. Accade come per i prigionieri della caverna di Platone, i quali, vedendo di fronte a loro le ombre che si muovono sulla parete, pensano che siano l’unica realtà da conoscere.
“Questo desiderio di semplificazione è giustificato, continua Primo Levi, la semplificazione non sempre lo è. È un’ipotesi di lavoro, utile in quanto sia riconosciuta come tale e non scambiata per la realtà; la maggior parte dei fenomeni storici e naturali non sono semplici, o non semplici della semplicità che piacerebbe a noi”[8].
Per Primo Levi il desiderio di semplificazione, il fatto cioè che noi abbiamo comunque bisogno di filtrare il rumore che ci perviene dal mondo, di ordinarlo in suoni che abbiano un senso e un significato, di fare una scelta, nel passaggio dal rumore all’ordine, che implica il lasciar fuori una gran parte degli eventi del mondo, si può anche giustificare, perché la nostra conoscenza è limitata, ma la semplificazione, il pretendere cioè che la nostra conoscenza del mondo corrisponda ontologicamente al mondo, è un errore. Tale pretesa infatti risponde molto di più a una strategia di rassicurazione che a una strategia della conoscenza. Noi viviamo in un mondo ansiogeno, e cerchiamo delle rassicurazioni. Non ci sarebbe niente di male in questo bisogno umanissimo, se non fosse però che esso tende a trasformarsi in un mezzo di riproduzione del dominio e della sudditanza.
La rassicurazione spinge verso la condizione di minorità, che diviene luogo di sicurezza a tutto danno dell’autonomia. La punta estrema di questa situazione è descritta in modo straordinario da Franz Kafka nel suo ultimo, incompiuto racconto La tana. Il protagonista esce dalla tana non per liberarsi da quell’ambiguo luogo che rappresenta nello stesso tempo la sicurezza e la prigionia, ma per poterla rimirare dall’esterno e confermare con l’uscita l’impossibilità di uscire.
Naturalizzazione e banalizzazione
La confusione tra semplificazione e desiderio di semplificazione è un momento di ciò che può essere definito un processo di naturalizzazione.
La naturalizzazione è quel processo che ci fa accettare il mondo così com’è, mostrandolo nell’immutevolezza della sua ovvietà. È un dare per scontata la nostra situazione nel mondo, ammessa come naturale ed eterna. È il processo mediante il quale le relazioni di potere appaiono, come per natura, stati di dominio.
Tale processo, che chiamo qui appunto naturalizzazione[9], affonda, tuttavia, le sue radici in un altro processo, questa volta necessario alla nostra vita individuale e sociale, un processo che possiamo qui chiamare banalizzazione.
Noi abbiamo bisogno di banalizzare il mondo che ci circonda, di incorporarlo attraverso l’apprendimento. Così, per esempio, impariamo a guidare l’automobile banalizzando tutti gli atti necessari alla guida, cioè all’azione umana che si rapporta alla macchina. Ma prima ancora avevamo imparato da piccoli a camminare, banalizzando il rapporto con l’ambiente attraverso il movimento delle gambe e, prima ancora, banalizzando il movimento stesso delle gambe. E poi avevamo imparato a mangiare con le posate, ecc.
In un certo senso il concetto di banalizzazione corrisponde a quello di abituazione che è così definito da Steven Rose nel suo ultimo, recente libro: “Le planarie hanno cellule sensibili alla luce conficcate entro cavità della loro testa, evitano la luce e reagiscono al contatto e ai gradienti chimici. Se toccate una planaria con una bacchetta essa si arriccerà formando una palla, la sua risposta al pericolo. Lentamente e cautamente poi si srotolerà di nuovo. Toccatela un’altra volta ed essa tornerà ad arrotolarsi. Ma se l’operazione viene ripetuta un numero di volte sufficiente, la risposta diminuirà e alla fine la planaria non risponderà più – si è abituata alla stimolazione della bacchetta e non la considera più come un pericolo. Tale processo è chiamato abituazione ed è una proprietà universale dei sistemi nervosi. Potrebbe essere considerato come una forma primitiva di apprendimento, e i suoi meccanismi biochimici sono stati studiati approfonditamente.
Tutti noi sperimentiamo tale fenomeno diverse volte al giorno, a partire dal momento in cui ci vestiamo al mattino. All’inizio avvertiamo molto la sensazione degli abiti contro la pelle, ma in breve tempo cessiamo di notarla. Ma se la natura dello stimolo viene leggermente modificata, se ad esempio i nostri vestiti inaspettatamente sfregano contro qualcosa – o, nel caso della planaria, se il tocco della bacchetta è accoppiato a uno schizzo d’acqua – allora la risposta completa si ripresenta immediatamente. Noi avvertiamo il nuovo, la presenza dei nostri vestiti; la planaria sente il pericolo e torna ad arrotolarsi in una palla. L’abituazione non avviene semplicemente perché l’animale è stanco o per il logoramento di qualche meccanismo chimico, ma è una modalità di adattamento basata sull’esperienza. E nemmeno l’abituazione è un cambiamento permanente del comportamento; trascorso un tempo sufficiente la risposta originaria si ripresenta”[10]
Noi abbiamo bisogno di banalizzare l’ambiente. Ma questo stesso processo, necessario alla vita, diventa lo strumento della naturalizzazione con cui il potere si autolegittima.Così come il patologico non è altro dal normale[11], ma una sua amplificazione, la naturalizzazione non è altro dalla banalizzazione, ma una sua amplificazione. Che cos’è dunque la naturalizzazione? È quel processo che realizza la nostra tendenza banalizzante a concepire le relazioni, i contesti, i passaggi, i prodotti della nostra attività e del nostro lavoro, la nostra stessa attività simbolica, come naturali e eterni e a dimenticarne storicità e artificialità. Essa tende a toglierci ogni responsabilità attribuendo alla natura quel potere di norma che pertiene a noi in quanto animali sociali e storici. La naturalizzazione comporta una perdita di memoria perché nega che un fenomeno abbia avuto o abbia un inizio e una fine, cioè una storia.
La contingenza della storia
“Una spiegazione storica, scrive Stephen Jay Gould, non si fonda su deduzioni dirette da leggi di natura, bensì da una sequenza imprevedibile di stati antecedenti, in cui ogni mutamento importante in qualsiasi passo della sequenza avrebbe modificato il risultato finale. Questo perciò è dipendente, o contingente, da tutto ciò che è venuto prima: la firma incancellabile e determinante della storia”[12].
Gould attribuisce direttamente a Darwin[13] tale idea di spiegazione storica. Una conseguenza è l’eliminazione del futuro come elemento prevedibile e controllabile e come mezzo di rassicurazione sulla pretesa centralità cosmologica della storia umana. Gould sostiene esplicitamente la contrapposizione tra contingenza e prevedibilità nella storia.
“Vorrei fare un’osservazione finale – egli scrive – sulla contrapposizione fra prevedibilità e contingenza. Io sto davvero sostenendo che nulla della storia della vita potrebbe essere predetto, o potrebbe seguire direttamente da leggi generali della natura? Ovviamente no; il problema che ci si pone è un problema di scala, o di livello di messa a fuoco. La vita presenta una struttura che obbedisce a principi fisici. Noi non viviamo in un caos di circostanze storiche, le quali non risentano di nulla che sia accessibile al ‘metodo scientifico’ qual è concepito tradizionalmente.”[14].
La contrapposizione tra contingenza e prevedibilità degli eventi storici porta con sé la separazione tra storia e futuro. Già Pascal, per esempio, aveva fatto affiorare simile contrapposizione e tale separazione, quando, riflettendo sull’infinità dell’universo, dette un’interpretazione nichilistica della vita umana nel cosmo[15]. Ma Pascal, pur consapevole della fragilità umana di fronte all’universo, pensava che l’uomo potesse tuttavia continuare a mantenere la propria superiorità rispetto al resto del cosmo grazie al fatto di essere dotato di coscienza[16]. Ma anche quest’ultima illusione di superiorità, a cui Pascal ancora si attaccava, sarebbe alla fine svanita. E con essa l’idea di una storia in grado di segnalare tale pretesa superiorità.
La nozione di ‘contingenza’ si oppone a che la storia intrattenga relazioni di sudditanza con concetti come ‘futuro, progresso, coscienza’.
Perdite di memoria
È un’epoca confusa, questa. Non più difficile di quelle passate. Più confusa sì. E nella confusione accadono cose contraddittorie. Interessanti e stupide. Attraenti e ripugnanti. Nel campo dell’arte, le nuove tecnologie aiutano gli artisti a fare quello che devono fare, cioè a guardare con altri occhi e a far guardare con altri occhi. I vecchi temi, le fiabe, i racconti, la tradizione orale e la tradizione scritta, si mettono insieme a fare un viaggio in cui le cose si mescolano restando sé stesse. Qui la memoria resiste per la semplice ragione che è rinnovata. Pinocchio o Amleto acquistano una dimensione diversa, ma senza perdere i loro tratti caratteristici. Si tratta anche di un esercizio di memoria, di quell’esercizio grazie al quale riconoscendo i tratti familiari di qualcosa che ci è noto, riusciamo a cogliere, anche proprio per questo, il mutamento di senso che le storie narrate ora comunicano.
Il feticismo delle merci domina a tal punto che non ci accorgiamo di quanto ci sia entrato dentro, si sia naturalizzato, insinuato nel nostro modo di essere. Domina il nostro attuale senso del mutamento. La differenza che il pubblicitario ci fa cogliere tra una merce e l’altra che le è concorrenziale e che le somiglia, non ha propriamente a che fare con il mutamento. Si tratta invece della differenza di quel gioco del mercato che sta condizionando tutto il nostro modo di vivere e di pensare, a cui soggiacciamo quasi senza rendercene conto. È il gioco del cambiamento debole, la finta orgia del nuovo, che si propone incessantemente come un valore e che, proprio a causa di quell’incessantemente, si è logorato. Il conformismo oggi ha i tratti del nuovo e del cambiamento. Viviamo l’epoca della caricatura della modernità. La finta orgia del nuovo uccide la memoria. Tutto è nel calderone del già dimenticato. Tutto è confuso. Un tempo tornare al passato era ritenuto necessario per comprendere sé stessi, ora al passato ci si va con veloci viaggi organizzati, vitto e alloggio compresi nel prezzo (bevande escluse), giusto il tempo di qualche veloce e fugace fotografia.
È un’epoca confusa. Produce attrazione e ripugnanza. Vecchi conformismi sono per fortuna saltati. Ma se ne affacciano di nuovi. La perdita di memoria facilita loro la strada. Dobbiamo domandarci: cosa vi è di democratico, di giusto, di buono in una perfetta visione del mondo dove il senso della critica si dissolve nei mille rivoli di un fiume che non scorre, dove non vi è più spazio per guardare con altri occhi? Siamo sempre più dentro la caverna di Platone.
La memoria oggi si annebbia in pochi giorni nello spazio televisivo e dei social. Stiamo entrando sempre più dentro un sistema di vita dove le libertà istituzionali tendono a intrecciarsi con una subliminale perdita delle autonomie collettive e individuali, dove il culto del successo, dietro la sua apparente dinamicità, stilla messaggi spietati e autoritari, dove il ritorno delle gerarchie rappresenta il contrassegno della perdita dell’eguaglianza nelle sue varie forme (economiche, culturali, psicologiche, istituzionali). Si accentueranno processi che si muovono verso una sempre più forte divaricazione fra ceti forti e ceti deboli.
La paura, accentuando oltre ogni dire il bisogno di rassicurazione, spinge i cittadini a mettere insieme, in un confuso alternarsi di concorrenza e cooperazione, scienza, tecnologia, religione, magia, delegandoli al ruolo di strumenti di salvezza più o meno illusoriamente efficaci. Una salvezza che, quanto più si mostra a portata di mano grazie ai mezzi di comunicazione di massa, tanto più è lontana e aleatoria. La ricerca di sicurezza alla fine rischia di dovere essere pagata al prezzo della libertà e dell’autonomia.
Ha scritto Gregory Bateson:
Si direbbe che ogni progresso scientifico importante fornisca strumenti che in apparenza sembrano rispondere perfettamente ai bisogni dei tecnici e degli ingegneri, i quali di solito partono in quarta senza stare troppo a riflettere. I loro sforzi benintenzionati (ma un tantino ingordi e un tantino troppo zelanti), se portano vantaggi, provocano anche parecchi danni, e al massimo servono a portare in primo piano lo strato successivo di problemi, che devono essere compresi prima di lasciare mano libera a tecnici…Ma il mondo, ci dicono, il mondo affamato, sovrappopolato, malato, ambizioso e competitivo non vuole aspettare che se ne sappia di più; deve precipitarsi là dove gli angeli esitano a metter piede.
Ho scarsissima simpatia per questi argomenti che invocano il bisogno del mondo, e se non sbaglio coloro che si fanno avvocati di questi bisogni sono spesso ben pagati. Non mi convince la risposta di quei tecnici che accampano l’utilità e la necessità di ciò che fanno. Ho il sospetto che il loro impaziente entusiasmo per l’azione, la loro smaniosa voglia di fare, non sia solo sintomo d’impazienza e neppure semplice ingordigia piratesca. Ho il sospetto che in realtà essi nascondano un profondo panico epistemologico[17].
Nel più grande romanzo marino del XIX secolo, Moby Dick, la storia della caccia che il capitano Achab e i suoi marinai danno alla mitica balena bianca, Herman Melville ci trasmette questo pensiero del suo ossessivo, sinistro e tragico protagonista: “nel suo cuore Achab aveva qualche sentore di ciò; vale a dire: tutti i miei mezzi sono sani, il mio movente e il mio fine insensati” (traduzione di Cesare Pavese). Si tratta di una straordinaria metafora del nostro mondo. I mezzi sono razionali, il fine folle. Alla fine del romanzo nessuno si salva tranne la balena bianca e Ismaele, il narratore. Nei nostri spesso spregiudicati rapporti con l’ambiente e con gli uomini noi corriamo un rischio ancora più grande, e cioè che non si salvino neppure il grande capodoglio e colui può e deve raccontare la storia.
[1]Atlan, Henri. “Complessità, disordine e autocreazione del significato”, 174. In Atlan, Henri, Gianluca Bocchi, cur., e Mauro Ceruti, cur. La sfida della complessità. Milano: Feltrinelli, 1997.
[2]Henri, 174.
[3]Henri, 174-175.
[4]Henri, 176.
[5]Levi, Primo. I sommersi e i salvati, 24. Torino: Einaudi, 1986.
[6]Levi, 24.
[7]Vico, Giambattista, e Manuela Sanna, cur. De Antiquissima, 22-23.Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 2005.
[8]Vico, 25.
[9]Sulla differenza tra naturalizzazione e banalizzazione, mi sia permesso di rinviare al mio Autonomia, potere, minorità, Milano: Feltrinelli, 2000.
[10]Rose, Steven. Il cervello del ventunesimo secolo, 47-48. Torino: Codice, Torino, 2005.
[11]Canguilhem, Georges. Il normale e il patologico. Torino: Einaudi, 1988.
[12]Gould, Stephen Jay. La vita meravigliosa. 290-291. Milano: Feltrinelli, 1990.
[13]Gould, 299. Nello schema di Darwin, noi non siamo un fine o l’incarnazione del tutto, ma rientriamo nei ‘particolari, buoni o cattivi, [lasciati] all’azione di quello che possiamo chiamare caso’. Se l’origine evolutiva di una qualsiasi forma di intelligenza cosciente di sé si trovi sopra o sotto questo confine, io semplicemente non lo so. Tutto ciò che possiamo dire è che il nostro pianeta non si è mai avvicinato una seconda volta a sviluppare una forma di autocoscienza. In Gould, 298 il riferimento allo scambio di lettere tra Darwin e Gray.
[14]Gould, 297.
[15]Sul nichilismo di Pascal: le osservazioni di Jonas, Hans e Raffaele Farina, cur. Lo gnosticismo, 337-338. Torino: S.E.I., 1991.
[16]L’uomo è solo una canna, la più fragile della natura, ma una canna che pensa. Non occorre che l’universo intero si armi per annientarlo; un vapore, una goccia d’acqua bastano a ucciderlo. Ma, quand’anche l’universo lo schiacciasse, l’uomo sarebbe pur sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire, e la superiorità che l’universo ha su di lui; mentre l’universo non ne sa nulla (Pascal, Blaise e Paolo Serini, cur. Pensieri, 377 – in Brunschvicg, fr. 347. Milano: Mondatori, 1979).
[17]Bateson, Gregory. Dove gli angeli esitano, 31. Milano: Adelphi, 1989.