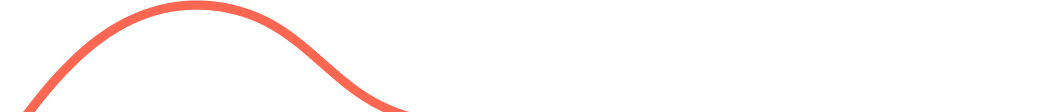Memoria, percezione e cecità
Intero numero disponibile qui.
Silvia Manca, Università Europea di Roma, ORCID ID: 0009-0005-1969-4086
E-mail: manca.silvi@gmail.com
doi: 10.14672/vds20231pr4
(https://doi.org/10.14672/vds20231pr4)
Paper accettato da 3/3 revisori
Revisioni di:
Aldo Meccariello, Direttore della rivista Il Contributo
Paolo Ercolani, Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Antonio Cecere, Università Tor Vergata di Roma
Abstract
In Mémoires d’aveugle, Jacques Derrida parla dell’accecamento, dell’invisibile che starebbe all’origine del disegno. Ricordando come la percezione appartenga sin dall’origine al ricordo, evidenzia l’impotenza originaria dell’occhio a vedere e, proprio come aveva già fatto J. Lacan in precedenza, ascrive l’ambito della visione al campo del desiderio piuttosto che a quello di un’istanza conoscitiva.
Keywords: Derrida, accecamento, percezione e memoria, rammendo, invisto
In Mémoires d’aveugle, Jacques Derrida talks about blindness, the invisible that would be at the origin of the drawing. Recalling how perception belongs from the beginning to memory, he highlights the original impotence of the eye to see and, just as J. Lacan had already done previously, he ascribes the sphere of vision to the field of desire rather than to that of a cognitive instance.
Keywords: Derrida, blinding, perception and memory, mending, unseeing
In Memorie di cieco[1], Jacques Derrida parla dell’accecamento, dell’invisibile che starebbe all’origine del disegno. Secondo il filosofo ebreo algerino e naturalizzato francese, nel momento in cui si scrive, si disegna, si traccia non si vedrebbe letteralmente niente di ciò che si traccia. La scrittura e, più in generale, la traccia grafica, si dedicherebbe all’anticipazione e, a differenza della precipitazione che esporrebbe maggiormente ‘la testa’, l’anticipazione riguarderebbe piuttosto ‘la mano’.
Una mano che si avventura al posto della testa quasi per anticiparla, che avanza nello spazio per essere la prima a portarsi in avanti nel movimento della presa, una presa che, ben lungi dal considerarsi una forza che afferra, sarebbe, piuttosto, un esporsi al contatto, un sondare: quasi come un cieco che esplora a tentoni, a mano nuda o con un bastone, o con una…matita? Una storia del corpo, delle mani, del viso e degli occhi, dunque[2]? Una via della mano e una via dell’occhio nello stesso corpo?
Come scrive Federico Ferrari[3], due sono i pensieri del disegno o le ipotesi fondamentali che Derrida formula in una scrittura che si intreccia alle immagini in un rinvio senza fine. La prima delle due è detta “trascendentale”: disegno del disegno, paradossale condizione di possibilità del disegno, nella quale agirebbe una forza cieca. Colui che disegna è, infatti, cieco al tracciarsi del tratto, non vede ciò che fa. In lui agisce una sorta di accecamento a priori che gli impedisce di porre come oggetto visibile e rappresentabile ciò che permette l’atto di disegnare. Nella logica trascendentale l’origine del disegno resta invisibile. Ma, subentrando la seconda “logica”, quella sacrificale, questo invisibile o invisto apparirebbe in modo paradossale nella rappresentazione dei ciechi, nei disegni, cioè, il cui tema è la cecità.
Il pensiero del disegno esisterebbe tra questa sorta di double bind che sottende l’atto del disegnare: l’autore del disegno, nell’atto di tracciare, non vede quel che traccia. La mano e lo strumento, guidati da una forza cieca e invisibile, impedirebbero la vista. Una vista che sarebbe accecata dalla mano.
In suo soccorso giungerebbe solo la penombra di un ricordo che vaga nella memoria. Ed è proprio nel soggetto dei disegni o dipinti di ciechi che si conserverebbe questa memoria.
Disegnare un cieco sarebbe, in primo luogo, un mostrare le mani, facendo notare ciò che si disegna con l’aiuto di ciò con cui lo si disegna, usando il proprio corpo come strumento, la mano delle manipolazioni, il disegno come chirurgia. Ciò che qui sembra evidenziarsi sono la cecità che governerebbe la visione del disegno, il punto cieco dello sguardo che traccia la figura e l’impotenza originaria dell’occhio[4].
Questa impotenza, secondo Derrida, si articolerebbe in tre punti fondamentali. Innanzitutto, l’atto grafico, poiché sfugge al campo del visibile, si definisce come a-prospettico, apertura sul punctum caecum[5] della vista e di ogni speculazione. Di conseguenza, il disegno non sarebbe mai, in nessun caso, mimetico e tra la cosa disegnata e il tratto che la mette in immagine resterebbe un’abissale eterogeneità. In secondo luogo, una volta che il tratto è tracciato subentrerebbe – per Derrida – il ritrarsi o l’in-apparenza differenziale del tratto. Il tratto sarebbe sempre rinvio ad altro, in rapporto a.
Il ritrarsi del tratto aprirebbe poi ad una terza fase del pensiero del disegno: la scrittura come archi-traccia, traccia originaria capace di far avanzare l’invisto. Derrida ricorda che la visione non si accontenterebbe più della sola vista, ma, piuttosto, creerebbe una sorta di interdipendenza, un rinvio infinito, con il tatto:
nella potenza tracciante del tratto, nell’istante in cui la punta della mano (del corpo in generale) si spinge avanti a contatto della superficie, l’inscrizione dell’inscrittibile non si vede […] La mia ipotesi […] è che il disegnatore si veda sempre in preda a ciò che, ogni volta universale e singolare, bisognerebbe chiamare l’invisto, come si dice l’insaputo. Il disegnatore se lo ricorda, è chiamato, affascinato o ricordato da esso. Memoria o meno, e l’oblio come memoria, in memoria e senza memoria[6].
Il tratto tracciato dalla mano, dal corpo, sfuggirebbe al campo visibile. Il disegnatore, come il chirurgo, come il cieco, non guarda le sue mani mentre traccia. E non perché il tratto non sia ancora visibile, ma perché non apparterrebbe all’ordine dello spettacolo, del visibile[7]. Poiché “la visione non è in grado di riferire con esattezza quanto ha percepito nel corso del suo viaggio”[8]. Quasi un tracciare senza vedere, un gesto che sembrerebbe rimandare ad un accecamento che cancellerebbe e disperderebbe quello che traccia evocando un’estetica, fino a qui, che sembrerebbe contrapporsi a tutta la storia, a tutta la semantica dell’idea europea, nella sua genealogia greca, che avrebbe da sempre assegnato il vedere al conoscere (idein, eidos, idea)[9] e nel quale il Sole platonico intelligibile, ossia il Bene assoluto che avrebbe generato sia l’essere sia la visibilità dell’essere, avrebbe avuto proprio le sembianze dell’occhio. La stessa spelonca platonica sembrerebbe aver sviluppato in tal senso un’immagine di tutti gli accecamenti possibili. I prigionieri incatenati sin dall’infanzia, ancora ciechi dell’idea delle cose stesse di cui contemplano le ombre proiettate dal fuoco sulla parete che sta loro di fronte sono immobili, non protendono mai le mani in avanti, si intrattengono, parlano di memoria. Ancora, a proposito di memoria, percezione e cecità, Derrida ricorda che ci sono tanti ciechi sia nell’Antico sia nel Nuovo Testamento[10]. Ed:
è sempre l’altro che non vedeva ancora. È sempre l’altro che vedeva con un occhio troppo naturale, troppo carnale, troppo esteriore, vale a dire letterale. Accecamento alla lettera e mediante la lettera. Simbolo: la sinagoga dagli occhi bendati. I farisei, gli uomini della lettera, sono in fondo dei ciechi. Non vedono niente perché guardano all’esterno, solamente il fuori. Bisogna convertirli all’interiorità […] accusare il corpo e l’esteriorità della lettera[11].
L’iconologo E. Panofsky ricordava come la Sinagoga venisse rappresentata cieca e associata con la Notte, la Morte, il diavolo e animali impuri[12]. Secondo Derrida anche i Vangeli si potrebbero leggere come un’anamnesi dell’accecamento. L’avvento avrebbe dunque luogo secondo la storia dell’occhio. E, si potrebbe aggiungere, della mano, poiché Gesù guarisce i ciechi semplicemente toccandoli. Il cieco tramite la sua vista recuperata diventa un testimone della verità, della luce divina. Il tocco, il movimento – ancora – chirurgico, la manipolazione, sarebbe anche ciò che orienta il disegno.
L’accecamento sarebbe spesso il prezzo – sacrificale – da pagare per chi deve finalmente aprire gli occhi, allo scopo di recuperare una via naturale o l’accesso a una luce naturale. Il paradosso starebbe nel fatto che il cieco diventerebbe in questo modo il miglior testimone, un testimone eletto. E un testimone, in quanto tale, è sempre cieco poiché la testimonianza sostituisce il racconto, la memoria, alla percezione. Il testimone sarebbe dunque un “archivista della visibilità” proprio come il disegnatore? Derrida avanza l’ipotesi che questa sia una delle ragioni per cui un disegnatore sarebbe sempre interessato ai ciechi.
Una scena testamentaria implica per lo meno, con il supplemento di una generazione, il terzo che vede, la mediazione di un testimone lucido. Costui, con un racconto o con una firma, attesterebbe di aver davvero visto, autentificando in tal modo l’atto di memoria per i posteri, gli spettatori, un eventuale quarto partecipante di questa scena.
Derrida ricorda che anche Baudelaire riferisce l’invisibilità del modello alla memoria che l’ha portato e si inserisce così in una tradizione che rende l’invisibilità ed assegna la stessa origine del disegno e della pittura, che danno luogo a rappresentazioni multiple, alla memoria piuttosto che alla percezione inscrivendosi così in una tradizione iconografica in memoria di Butade, “la giovane amante corinzia che portava il nome del padre”[13], un vasaio corinzio considerato l’inventore dell’arte di modellare l’argilla in rilievo.
Secondo lo scrittore romano Plinio il Vecchio[14], la giovane figlia del vasaio Butade Sicionio, Cora di Sicione, era innamorata di un coetaneo a Corinto, città nella quale vivevano. Poiché il ragazzo doveva partire, Cora tratteggiò con una linea l’ombra del volto del suo giovane amante proiettata sul muro dal lume di una lanterna e su questo profilo suo padre Butades impresse l’argilla riproducendone il volto che poi fece essiccare e cuocere in forno insieme alle tegole e al resto del suo vasellame in creta. In questa storia nel quale il vasaio deve la sua invenzione alla giovane figlia innamorata, l’origine del disegno e della pittura danno luogo a rappresentazioni che sostituiscono la memoria alla percezione. Innanzitutto, perché queste sono rappresentazioni e poi perché questo racconto riporta l’origine della rappresentazione grafica all’assenza o all’invisibilità del modello. Cora e Butade non vedono il soggetto di cui tracciano i contorni e i cui contorni imprimono né/con l’argilla:
come se per disegnare fosse vietato vedere, come se non si disegnasse che a condizione di non vedere, come se il disegno fosse una dichiarazione d’amore destinata o ordinata all’invisibilità dell’altro […] questa scrittura d’ombra inaugura un’arte dell’accecamento. La percezione appartiene sin dall’origine al ricordo[15].
Memoria e percezione. Senza la memoria, infatti, come si potrebbe percepire, decidere, pianificare, parlare, disegnare, persino riconoscere…l’ombra di chi si ama? E se la percezione apparterrebbe dunque sin dall’origine al ricordo, non sarebbe qui opportuno ricordare che la testimonianza che sostituisce il racconto, la memoria, alla percezione, consisterebbe pur sempre in un ricordare che, per la sua stessa natura, procede a tentoni proprio come le mani di un cieco?
Lo stesso atto di riportare alla memoria una traccia mnestica, non è forse da considerarsi un atto che, ben lungi dall’essere un ripescare da uno statico archivio, si configura, piuttosto, come un atto di ricostruzione/riconfigurazione plastica e dinamica alla luce di un nuovo contesto da pensarsi persino in termini di […] rilevanza adattiva[16]?
Questo atto di memoria così inteso sarebbe dunque ben lungi dall’essere una rassicurante testimonianza e certezza, e non sembrerebbe, piuttosto, somigliare alla bacchetta di Butade e/o al bastone di un cieco? Un’arte dell’accecamento inaugurata da chi si è reso cieco, che si è “estirpato-castrato gli occhi”, per rendere visibile –disegnando – il contorno dell’amante assente? Il visibile in quanto tale sarebbe dunque, forse, invisibile? Derrida ricorda l’ultimo M. Merleau-Ponty:
quando dico dunque che ogni visibile è invisibile, che la percezione è imperfezione, che la coscienza ha un ‘punctum caecum’, che vedere è sempre vedere più di quanto si veda […] si deve comprendere che è la visibilità stessa a comportare una non-visibilità. Ciò che essa (la coscienza) non vede, non lo vede […] perché è coscienza. Ciò che essa non vede è ciò che in essa prepara la visione del resto[17].
La prospettiva derridiana sembra considerare questo punctum caecum quasi come un indice analogico della visione stessa: quella che, pur volendosi vedere, non si riflette, non si pensa in modo speculare o speculativo e che dunque si acceca nel punto del narcisismo, in ciò stesso dove essa si vede guardare? Un tracciato, a ‘ben guardare’, non si vede. Il tratto, la linea, non è più ciò che è, poiché da questo momento non si rapporta mai a sé stessa senza dividersi subito, secondo Derrida.
Il disegno farebbe dunque sempre segno verso l’inaccessibilità? Verso la soglia dove non appare che l’intorno del tratto, ciò che spazia delimitando e che dunque non gli appartiene? Per Derrida niente appartiene al tratto, dunque al disegno e al pensiero del disegno, neanche la propria traccia. Il tracciato separa e separa sé stesso, è spaziatura senza appropriazione possibile. Dunque:
‘prima di’ tutte le interpretazioni, le oftalmologie, le teo-psicoanalisi del sacrificio o della castrazione, vi sarebbe il ritmo eclittico del tratto, la gelosia, la contrazione aboculare che dà a vedere “a partire da” l’invisto […] Ovunque il disegno formi una consonanza e si articoli con un’onda sonora e temporale, il suo ritmo viene a patti con l’invisibile[18].
Il ritrarsi della linea, ciò che la ritira nel momento in cui il tratto si tira, lascerebbe poi la parola, inaugurando la sua ben nota egemonia. E in questa ipotesi della vista derridiana, non poteva mancare l’ipotesi dell’autoritratto del disegnatore come autoritrattista. Vedendolo di fronte, lo spettatore o l’interprete che noi siamo deve immaginare che il disegnatore non fissi che un punto, il fuoco di uno specchio di fronte a lui, ossia al posto che noi occupiamo, come faccia a faccia con lui: questo non può essere l’autoritratto di un autoritratto che per l’altro, per uno spettatore che occupa il posto di un unico fuoco, ma al centro di ciò che dovrebbe essere uno specchio.
Lo spettatore, allora, rimpiazzerebbe e oscurerebbe lo specchio, rendendo cieco con lo specchio e mettendo in opera la specularità ricercata. La prestazione dello spettatore così come gli è prescritta dall’opera consisterebbe nel colpire il firmatario d’accecamento, e dunque nel cavare nello stesso momento gli occhi del modello o, nel farlo a sé stesso, al soggetto: cavarsi gli occhi per vedersi e per rappresentarsi all’opera.
Se così fosse, l’autoritratto consisterebbe in primo luogo nell’assegnare il proprio posto allo spettatore a partire dallo sguardo di un disegnatore che da una parte non si vede più, essendo lo specchio rimpiazzato dal destinatario che gli sta di fronte, da noi stessi, ma che, tramite noi, d’altra parte, nel momento in cui siamo al posto dello specchio, non vediamo più l’autore in quanto tale. Non si può mai identificare un autoritratto come tale. In tutti i casi di autoritratto, solo un referente non visibile nel quadro, estrinseco, potrà permettere un’identificazione. Quest’ultima resterà sempre indiretta. Si potrà sempre dissociare il firmatario e il soggetto dell’autoritratto.
Secondo il filosofo, è proprio per questo che lo statuto dell’autoritratto dell’autoritrattista conserverà sempre un carattere di ipotesi, poiché esso dipende dall’effetto giuridico di un titolo che non appartiene all’interno dell’opera, ma soltanto alla sua bordatura parergonale. E l’effetto giuridico chiamerebbe alla testimonianza del terzo, alla sua parola, alla sua memoria. La finzione performativa che ingaggia lo spettatore nella firma dell’opera darebbe a vedere soltanto tramite l’accecamento che essa produce come sua verità…Dal momento in cui si considera affascinato, fermo sull’immagine, ma dileguantesi ai suoi propri occhi nell’abisso, il movimento tramite il quale un disegnatore tenta disperatamente di riafferrarsi sarebbe, dunque e già, nel suo presente stesso, un atto di…memoria?
Lo scacco nel riafferrare la presenza dello sguardo dall’abisso in cui sprofonda […] raffigura la possibilità stessa dell’opera, lo spettro dell’invisibile che l’opera dà a vedere senza mai presentarlo[19].
Ed è dunque per questo che l’autore dell’autoritratto si acceca nel momento in cui cerca di sorprendere il suo sguardo nello specchio? Per Jean-Luc Nancy, allievo ed amico di J. Derrida, il soggetto del ritratto non è nessun altro se non il soggetto stesso che “se ne va a fondo”. En abyme, nel fondo, nell’abisso dell’immagine, del quadro. Irretito, trascinato (per le mani?) da essa.
L’essenza della pittura verrebbe rispecchiata nel ritratto poiché, allorché il filosofo si interroghi sulla soggettività assoluta o sull’identità, necessariamente finirebbe per parlare di sfondamenti di superfici, di un altro sé diverso dalla semplice apparenza? Nancy individua nel ritratto l’ossimoro di uno sguardo cieco che è la visibilità stessa, la sua fondazione e premessa[20].
La caratteristica del ritratto sarebbe il suo essere apertura sul silenzio della propria presenza assente:
il ritratto ricorda la presenza, nei due sensi del termine ‘ricordo’: fa tornare dall’oblio dell’assenza e rammemora nell’assenza stessa. È in questo modo che il ritratto immortala: rende immortali alla morte. (Ma più esattamente forse: il ritratto immortala meno una persona di quanto non presenti la morte in una persona) […] Il ritratto mette la morte stessa all’opera […] e in pieno sguardo. La morte – o la castrazione – vale a dire ciò che si riduce ai concetti di ‘finitezza’ o di ‘divisione’ […] La memoria alla quale si fa allora appello non è la conservazione di un presente passato: è il rinculo o la rimonta verso il fondo sempre presente – e propriamente immemoriale – dell’assenza stessa.[21]
Nello sguardo si concentrerebbe dunque l’enigma dell’assenza presente (del soggetto) e della presenza assente (del senso)? Ma lo sguardo non è solo quello rappresentato, riprodotto, ma è anche lo sguardo stesso del quadro, perché “prima di ogni altra cosa, il ritratto guarda: non fa altro che questo, vi si concentra, vi si invia e vi si perde”[22]. Per Derrida, l’autoritratto è la rovina, il viso fissato come memoria di sé, ciò che resta o ritorna come uno spettro. E, per il filosofo, la rovina non sopraggiungerebbe, non verrebbe dopo l’opera. In principio sarebbe la rovina. Essa sarebbe prodotta dalla struttura dell’opera stessa. Senza alcuna promessa di restauro.
Rovina: la memoria aperta come un occhio, piuttosto, oppure lo squarcio di un’orbita ossea che vi lascia vedere senza niente mostrarvi del tutto. Per non mostrarvi niente del tutto […] Maschera di questo autoritratto impossibile il cui firmatario si vede sparire dai suoi propri occhi nella misura in cui tenta disperatamente di riafferrarvisi […] Il cui scatto stesso vorrebbe toccare il punto cieco di uno sguardo che si guarda negli occhi e non è lontano dallo sprofondarvisi[23].
Il viso nudo non può guardarsi in faccia, non può guardarsi in uno specchio. La figura vede allora la propria visibilità intaccata, impotente a riflettersi nell’ombra dell’autoritratto, per l’incompletezza del monumento visibile. Naturalmente, qui siamo ancora nel campo dell’immenso dominio del disegno degli uomini. Poiché:
qui accantoniamo la questione di ciò che viene oscuramente chiamato l’animale, il quale non è affatto incapace di tracce. Il limite lasciato qui in ombra appare tanto più mobile quanto necessariamente in esso si incrociano le “mostruosità” dell’occhio, figure zoo-teo-antropomorfiche, trapianti instabili o proliferanti, ibridi inclassificabili di cui le Gorgoni o i Ciclopi sono soltanto gli esempi più conosciuti. Si dice che la vista di certi animali sia più potente, più acuta, persino più crudele di quella dell’uomo – e tuttavia priva di sguardo[24].
Lo sguardo della conoscenza continuerebbe dunque a confrontarsi con l’occhio terribile di Medusa e con la cecità di Edipo che riconosce la sua colpa: ciò che non si può guardare in faccia senza vedersi significare l’obiettività pietrificata, la morte o l’accecamento? E il mito di Perseo “raffigura anche un indice, il dito di un disegnatore o il tratto di una struttura. Senza fronteggiare lo sguardo fatale di Medusa, ma soltanto il suo riflesso nello scudo di bronzo levigato come uno specchio, Perseo vede senza essere visto… nessuna intuizione diretta, soltanto angoli e obliquità dello sguardo”[25]. In tutte le tappe della storia di Perseo, ogni volta si tratterebbe di una storia dell’occhio[26].
E ogni volta l’astuzia sarebbe quella di uno sguardo obliquo[27] o indiretto che consisterebbe nello schivare piuttosto che nell’affrontare la morte che viene tramite gli occhi.
Come ricordava R. M. Rilke in una delle sue Elegie duinesi[28], in questo sarebbe la differenza tra lo sguardo dell’uomo e quello dell’animale: l’uomo mira qualcosa o qualcuno quando guarda, il suo sguardo è diretto, nell’animale, invece, lo sguardo è indiretto, perché lo sguardo diretto sarebbe sempre ostile…Poiché:
Decapitare = evirare. Il terrore davanti a Medusa è dunque il terrore dell’evirazione in quanto legata alla vista […] La vista della testa di Medusa, per l’orrore che suscita, irrigidisce lo spettatore, lo muta in pietra […] Irrigidimento, infatti, significa erezione, e quindi nella situazione originaria qualcosa che consola lo spettatore: costui ha ancora un pene, e di ciò si rassicura diventando rigido[29].
S. Freud stesso, ne L’inquietante estraneità (Das Unheimliche[30], 1919) illustra, con il riferimento a L’uomo della sabbia di Hoffmann, la sua più vistosa formulazione dell’equivalenza tra il timore per gli occhi e l’angoscia di castrazione. Il castigo dell’accecamento che si infligge Edipo, il criminale mitico, non sarebbe altro che una forma mitigata della pena dell’evirazione, la sola che – secondo la legge del taglione – sarebbe stata adeguata al suo caso.
Si tradurrà dunque accecamento con castrazione? – Si chiede Derrida. E:
Per illustrare la massiccia “verità” di questo assioma freudiano […] si dispone di tutto il materiale di una dimostrazione facile e clamorosa considerando la storia di Sansone…Costui perde ogni attributo o ogni sostituto fallico, i capelli e poi gli occhi, dopo che l’astuzia di Dalila ebbe eluso la sua vigilanza per abbandonarlo a una sorta di sacrificio, un sacrificio fisico. Non è soltanto figura della castrazione, figura-castrazione, egli stesso diventa da capo a piedi, un po’ come tutti i ciechi, i guerci o i Ciclopi, un’immagine falloide, un sesso svelato, vagamente osceno e inquietante […] Più nudo di un altro, un cieco diviene virtualmente il proprio sesso […] ‘Una sola vendetta per due occhi’, ‘i morti […] più numerosi’: in questa logica del supplemento sacrificale c’è sempre una ricompensa della rovina, il beneficio di un’usura, in breve un’ipoteca degli occhi e un premio per l’accecamento[31].
“Più nudo di un altro”, un cieco, forse perché si vede l’occhio stesso esibito nel suo corpo opaco, immobile, che non vede, che non si vede esposto allo sguardo dell’altro e che posso fissare senza essere visto fino all’indecenza, spogliato com’è della significazione dello sguardo che, appunto, sarebbe venuto allo stesso tempo ad animarlo e a velarlo? E inversamente, il corpo stesso dell’occhio, in quanto vede, sparirebbe nello sguardo dell’altro quando guardo qualcuno che vede, poiché secondo la legge del chiasmo, nell’incrociarsi o nel non-incrociarsi degli sguardi, si è tanto più ciechi all’occhio dell’altro quanto più quest’ultimo si mostra capace di vedere e quanto più possiamo scambiare uno sguardo con lui? E in questa analogia tra l’occhio e il sesso, quest’occhio di cui ha parlato Freud e che è stato ripreso da Derrida, sembra essere un occhio naturale, carnale, umano, anche troppo umano, così umano da saper versare anche, soprattutto… lacrime? In fondo, si è visto, quest’occhio non sarebbe più da considerarsi come un principio teoretico (theorèin = vedere), “in fondo all’occhio, quest’ultimo non sarebbe destinato a vedere, ma a piangere”[32]. Anche F. Nietzsche, ricorda Derrida, piangeva molto[33]. E definisce le Confessioni di Sant’Agostino come il libro delle lacrime. Sarebbe dunque proprio attraverso questo organo che esprime dei sentimenti che si suggerirebbe un’ipotesi diversa dai modi di comprensione della verità fondati sul vedere, sulla visibilità, sul visibile?
Le lacrime direbbero qualcosa dell’occhio che non ha più nulla a che vedere con la vista, a meno che non la rivelino ancora velandola: “Nel momento stesso in cui velano la vista, le lacrime svelerebbero il proprio dell’occhio”[34]. Per Derrida essi sarebbero l’essenza dell’occhio. E l’essenza dell’occhio sarebbe ciò che costituirebbe il proprio dell’uomo. Poiché sarebbe impossibile piangere con un occhio solo quando se ne hanno due. Due occhi possono sempre dissociarsi dal punto di vista della vista. Dal punto di vista della loro funzione organica. Ma è “tutto l’occhio”, il tutto dell’occhio che piange.
E la cecità non impedirebbe le lacrime, non priverebbe delle lacrime. Il filosofo sembrerebbe qui pronunciarsi a favore di un’ipotesi ab-oculare. Ma, non si rischia così di rientrare in una tradizione che ha sempre fatto del cieco un testimone privilegiato della verità, e della cecità la condizione per volgere l’attenzione all’interiorità[35]? Lacrime che vedono…crede veramente questo Derrida?
Non sarebbero forse da pensarsi, queste lacrime, piuttosto, come una sorgente smemorata che ha dimenticato la sua origine e che implora per sapere da dove esse discendano e da chi esse salgano agli occhi? Un’implorazione piuttosto che visione? Lacrime da intendersi come un lutto della vista che non può afferrare la propria identità e che si è persa nell’oscurità delle pupille? Sguardo velato che sfuma i contorni del senso, opacizzandoli? Era stato già J. Lacan, negli anni Sessanta del secolo scorso, ad inserire il privilegio dello sguardo nella funzione del Desiderio, ascrivendo l’ambito della visione al campo, appunto, del desiderio piuttosto che a quello di un’istanza conoscitiva[36].
Desiderio la cui opacità[37] ricordava costantemente che la coscienza non è mai assoluta e che esso stesso non può che essere inteso che come interna incoerenza della coscienza stessa. Questo sguardo che opererebbe dunque come una sorta di “discesa negli Inferi”, accenderebbe e trascinerebbe il soggetto che non può più staccarsi da ciò che è significante per lui, il desiderio dell’altro, all’altro?
Tale sarebbe dunque l’appetito dell’occhio che fa il valore fascinoso della pittura, il suo sortilegio? Poiché l’occhio porterebbe con sé anche la funzione mortifera di essere dotato di un valore separativo e, come la coscienza, che è scotòma, questa visione separativa andrebbe dunque “molto più lontano” di quella prospettica tradizionale? Così Derrida, sottolineando la funzione opacizzante, scotomizzante dell’occhio della coscienza, sembrerebbe aver dato vita ad un’estetica, in quanto tale, appunto, scotomizzata e scotomizzante.
Scotòma, il disturbo della vista che la opacizza per zone o del tutto, macchia tonda o irregolare che oscura una parte del campo visivo centrale e periferico. Oscuramento che fa brancolare nel buio (scotos = buio). E allora, per il timore di cadere, ecco che i ciechi di Derrida si appoggiano alla nera matita da disegno come ad un nero bastone? Ed ecco che questa estetica cieca, scotomizzata e scotomizzante derridiana si appoggia ad un Denis Diderot che scrive una lettera a Sophie Volland senza vedere, immerso nelle tenebre e “senza nessuna certezza di formare dei caratteri”[38].
F. Ferrari rintraccia in questa “scrittura notturna…e oscura, che cancella quello che traccia (e) disperde quello che dice”[39] dideroniana, la chiave stessa dell’intera estetica di Derrida:
La scrittura critica – da Diderot fino a Derrida, cioè dalla sua nascita moderna ai nostri giorni – è dunque scrittura di tenebra, indissolubilmente legata ad un accecamento, all’impossibilità di una definizione univoca o di una identificazione chiara del segno o dell’opera. Si tratta di una scrittura che non solo sconta una sorta di accecamento sul tema, ma che pure scrive a partire da un punto cieco. Assumendo questo accecamento originario e facendo del punto cieco il proprio tema […] la scrittura di Derrida […] rimette in gioco tutta la strategia della metafisica teleologica…che vede nell’opera d’arte un punto d’arrivo in cui si concentra tanto lo sforzo del genio romantico quanto il gesto creatore di un Dio minore (l’artista, secondo Shaftesbury). Con il suo gesto decostruttore […] rispondendo alla domanda estetica con una sorta di non risposta o di falsa risposta spaesante (Unheimliche), Derrida sottrae l’immagine ai confini in cui si trova costretta dalla tradizione: l’immagine non è più o non è solo un punto d’arrivo, ma la soglia in cui si può “veder venire” il suo stesso avvenire. L’immagine precipita […] (e) anticipa il suo non-ancora-visto o il suo invisto, rendendo necessario un avanzare a tentoni, come ciechi o non vedenti persi in un gioco di mosca cieca. L’atto grafico si definirebbe come aprospettico, proprio perché procederebbe nel buio della notte, sfuggendo al campo del visibile: aprospettiva come apertura – nuovamente – di un punctum caecum? Poiché lo sguardo non lo si può vedere, ma solo, piuttosto, intercettare, mentre sorprende, spaventa, facendo persino vergognare, irrompendo come una ventata che apre e che capovolge[40]?
È forse questa la corposità della funzione di sguardo, dell’essere, nello stesso tempo, macchia e quadro, guardante e guardato? È così che Derrida descriverebbe l’origine del disegno: un accecamento a priori. Poiché il disegnatore (o la disegnatrice?) è cieco al tracciarsi del tratto, non vede né il suo occhio né ciò che traccia, e si trova così irretito nella tela? Proprio come ogni autoritratto è uno specchio che inghiotte l’immagine di colui che lo guarda ed in cui l’autore scompare? Così il “cieco” Derrida, rammentando (o rammendando?) i reticoli, la trama della sua memoria, ricorderebbe dunque questo accecamento, questa invisibilità che darebbe origine al segno grafico? E la cecità rappresenterebbe dunque questa impotenza originaria a vedere dell’occhio? Poiché davanti al disegno “lo scacco nel riafferrare la presenza dello sguardo dall’abisso in cui sprofonda… raffigura la possibilità stessa dell’opera, lo spettro dell’invisibile che l’opera dà a vedere senza mai presentarsi”[41].
Per Derrida l’invisibilità è “l’infinitamente altro” e il segreto, la separazione, l’invisibilità di Gige[42], del vedere non essendo visti, rimanderebbero a ciò che si chiama psiche. Ciò che è invisibile sarebbe proprio il fantasma, una memoria di cieco o qualcos’altro ancora di indefinibile –forza cieca e invisibile – che spingerebbe a scrivere e a disegnare. E dunque, questa di Derrida, ricorda Federico Ferrari, sarebbe proprio da pensarsi come “un’estetica spettrale”[43].
Derrida sembrerebbe donare –ad occhi chiusi e a piene mani – rendere giustizia, agli spettri, allo sguardo dell’altro, di quell’altro che mai incroceremo? Questa estetica sembrerebbe proprio, appunto, fornire una (non) risposta critica spettrale e inquietante ed aprire l’opera sulla sua différance interna, che precipita la singolarità dell’opera nel qui e ora esponendola alla sua immanenza e alla sua urgenza, rinviandola all’a-venire.
Poiché “l’eredità – infatti – non è mai un dato, è sempre un compito”[44]. E nell’apertura di questa voragine, lo sguardo…si perde? Inoltrandosi nelle topiche dell’invisto, Derrida ha ricordato che la visione non può più accontentarsi della sola vista ma che, anzi, impone un trasporto verso gli altri sensi. Si è visto quanta importanza abbia, sulle orme della psicoanalisi, il recupero del corpo nella speculazione derridiana. Si è parlato di un’interdipendenza, un rinvio senza fine, di una correspondance baudelairiana, di mani, di occhi, orecchie…
L’occhio ascolta[45] – dice Claudel – quando il libro ha la vocazione di proferire il logos divino.
Per Derrida, invece, l’occhio proverebbe ad ascoltare solo colpi di gong sordi e ciechi, che risuonerebbero, sottomessi a un certo ritmo, in silenzio, nella zona più profonda del soggetto, nella sua zona cieca: la sua mémoire d’aveugle. E l’immagine, qualunque immagine – comprese quelle intrapsichiche – sarebbero dunque da considerarsi quasi come un punto cieco – piuttosto che un punto di arrivo – in cui è la vista stessa a perdersi? Poiché, se così fosse, ci vorrebbe forse “più d’un orecchio, più che un orecchio”[46]? E anche più d’un occhio, più che un occhio?
[1]Derrida, Jacques. Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines. Paris: Editions de la réunion des Musées Nationaux, 1990. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., e Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine. Milano: Abscondita, 2003. Questo testo nasce in occasione della mostra tenutasi nella Hall Napoléon del Louvre dal 26 ottobre al 21 gennaio 1991. La mostra comprendeva una quarantina di disegni, appartenenti esclusivamente alle collezioni del Louvre, riuniti secondo il multiplo filo conduttore proposto da Derrida: i legami tra il disegno, e l’autoritratto in particolare, e l’impossibilità di vedere, la memoria e la rovina, esplorati fino alle soglie di un’ipotetica conoscenza filosofica. Si tratta di una mostra in cui il testo è importante. Le opere riprodotte nel catalogo sono 70. Partendo dalla sua esperienza del disegno, che assimila a quella di un cieco, Derrida analizza questa tematica su una filigrana autobiografica. Egli spiega come «per ragioni familiari mi sento particolarmente incapace non solo di disegnare, ma anche di percepire e di analizzare i disegni, mi sento come un cieco, ho la sensazione di una vera e propria infermità di fronte al disegno; nel momento che ha preceduto la scelta del tema di questa mostra, poi, nella mia vita si sono verificati degli eventi che mi hanno condotto a riflettere sulla cecità… si tratta per me di scrivere le memorie del mio accecamento di fronte al disegno, ma nello stesso tempo di situare il tema del cieco nella memoria del disegno… nella mostra troviamo sguardi immersi nella notte, sotto l’ombra di un cappello, sguardi allucinati inabissati nella riflessione speculare…». Si veda anche l’intervista di Derrida Jacques con Colban Mottola, Luciana in Il giornale dell’arte n. 82, ottobre 1990.
[2]I disegni dei letterati sono letteratura […] si tratta in ogni caso di un vuoto, che vuoto non può rimanere e altrimenti non si può riempire. Quello che è certo […] è la somiglianza testuale tra pagina scritta e pagina disegnata. L’una e l’altra sono, oggettivamente, scrittura […] La pagina scritta è un fatto grafico e agli occhi di chi ignorasse la lingua in cui è scritta sarebbe nient’altro che un disegno. Si veda, a questo proposito, Argan, Giulio Carlo. “Ho una malattia, io vedo il linguaggio”, 21. In Barthes, Roland, e Achille Bonito Oliva, cur. Intermezzo. Milano: Skira, 2004. Tale testo fu edito in occasione della mostra Barthes. Intermezzo, Roma, Palazzo Venezia, 10 marzo – 9 maggio 2004.
[3]Ferrari, Federico. “L’eredità dell’avvenire. Riflessi di un’estetica spettrale”, 163-175. In Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., e Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine. Milano: Abscondita, 2003.
[4]Si vuole qui ricordare che anche Wittgenstein, Ludwig nel suo Tractatus, aveva trattato il tema della funzione della raffigurabilità ricordando che “l’occhio, in realtà, tu non lo vedi” e intendendo così che nessuna parte della nostra esperienza è a priori, che non c’è un ordine a priori delle cose. «Il soggetto che pensa, immagina, non v’è», «Tu dici che qui è proprio così come con occhio e campo visivo. Ma l’occhio non lo vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un occhio», «ciò inerisce al fatto che nessuna parte della nostra esperienza è anche a priori […] Tutto ciò che vediamo potrebbe essere altrimenti. Non v’è un ordine a priori delle cose». Si veda, pertanto, Wittgenstein, Ludwig e M. Caleo, cur. Il Tractatus logico-Philosophicus di L. Wittgenstein. Decifrato [Logisch-philosophische Abhaudlung], 203-204 [5.631, 5.633, 5.634]. Lancusi (SA): Elea Press, 1996.
[5]Sul punctum si veda anche Barthes, Roland: «un supplemento: è quello che io aggiungo alla foto e che tuttavia è già nella foto […] Non appena vi è punctum, subito si crea (si presagisce) un campo cieco […] Il punctum è una specie di sottile fuori-campo, come se l’immagine proiettasse il desiderio al di là di ciò che essa dà a vedere». Si veda Barthes, Roland e Remo Guidieri, cur. La camera chiara. Nota sulla fotografia, 56, 58, 60. Torino: Einaudi, 2003.
L’ultimo Barthes, accogliendo suggestioni della psicanalisi lacaniana, rifiuta una prospettiva logocentrica ed individua nel corpo il centro della conoscenza e nel piacere il principio euristico fondamentale. Il punctum sarebbe una puntura inferta solo da alcune immagini: esso consiste in un dettaglio che spiazza l’osservatore senza che egli possa spiegarne il motivo. Sorta di significante che spiazza e sorprende il soggetto – per dirla in termini lacaniani. Dallo stupore afasico provocato dall’unicità del referente si passa poi, in Derrida, ad una distensione o espansione del punctum in una dimensione di durata che comprende le tecniche di produzione, diffusione, archiviazione dell’immagine. Si veda Angeleri, Luciana. La figura moderna dell’autore.
[6]Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine, 62-64. Milano: Abscondita, 2003.
[7]Si vuole qui ricordare che non si tratta più della vecchia querelle che vede l’immagine contrapporsi alla parola, poiché entrambe appartengono all’ordine del visibile. La differenza è, piuttosto, tra la parola, l’immagine e quel che non è dell’ordine del dire e del vedere. Per indicare sia parola che immagine – e anche, quindi, favola, fato, fantasia, fantasma, è utilizzata infatti la stessa radice sanscrita bha. Si veda Proietti, Maria Letizia. “La questione dell’immaginazione tra coscienza e inconscio: per un altro orizzonte critico”, 351. In Proietti, Maria Letizia, Maria Dalai Emiliani e Stefano Marconi, cur. Scritti e immagini in onore di Corrado Maltese. Roma: Quasar, 1997.
[8]De Man, Paul, ed Eduardo Saccone, cur. Cecità e visione/Linguaggio letterario e critica contemporanea, 132. Napoli: Liguori, 1975. Per De Man, anche il critico è cieco al proprio enunciato, proprio come l’artista alla sua opera. Resta sempre uno scarto – che resta a lui celato – tra il metodo dichiarato e la percezione critica: «Non solo il critico dice qualcosa che l’opera non dice, ma egli dice persino qualcosa ch’egli stesso non intende dire». De Man, 136. Sull’argomento si veda anche: Derrida, Jacques. Mémoires pour Paul de Man. Paris: Galilée, 1988. Edizione italiana : Derrida, Jacques, Giovanna Borradori, cur. ed Enzo Costa, cur. Memorie per Paul De Man. Saggio sull’autobiografia. Milano: Jaca Book, 1995.
[9]Derrida, Memorie di cieco, 23.
[10]Derrida nota come i ciechi gloriosi della nostra cultura sono quasi sempre uomini, «grandi ciechi», «come se la donna forse vedesse senza mai rischiare di perdere la vista, e l’assenza di “grandi cieche” non sarà un fatto senza conseguenze per le nostre ipotesi – , si direbbe che non si perdano nell’erranza assoluta. Esplorano – e cercano di prevedere là dove non vedono, non vedono più o non vedono ancora. Lo spazio dei ciechi coniuga sempre questi tre tempi di memoria». Derrida, Memorie di cieco, 17-18. E, nelle pagine citate, «Sempre come ipotesi della vista. Donne cieche ve ne sono, certo, e di loro si parla, ma poco, appunto. Ve ne sono poche e se ne parla poco. Sante, più che eroine […] ma né la cultura biblica né la cultura greca conferiscono alle donne un ruolo esemplare nelle grandi gesta paradigmatiche della cecità. Queste gesta sono dominate dalla filiazione padre/figlio che vedremo ossessionare tanti disegni. In compenso, il fatto che all’origine del disegno vi sia una figura di disegnatrice, Butade, ad esempio, dovrà chiarire più che insidiare il nostro punto di vista».
[11]Derrida, 32.
[12]Panofsky, Erwin. Studi di iconologia. I temi umanistici dell’arte del Rinascimento, 26. Tradotto da Renato Pedio. Torino: Einaudi, 1975.
[13]Derrida, 68.
[14]Plinio Il Vecchio, Naturalis historia, XXXV, 15 e 151.
[15] Derrida, 67-68.
[16]Baddeley, Alan. La memoria umana. Teoria e pratica. Tradotto da Marco Ricucci. Bologna: Il Mulino, 1995. Bartlett, Frederic C. Remembering. A study in experimental and social psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1932. Brandimonte, Maria A. Psicologia della memoria. Roma: Carocci, 2004. D’Ambrosio, Antonio, e Pasquale Supino. La sindrome dei falsi ricordi. Cosa sono i falsi ricordi, come individuarli e ridurne il rischio. Milano: FrancoAngeli, 2014.
[17]Merleau-Ponty, Maurice, Mauro Carbone, cur., e Claude Lefort, cur. Il visibile e l’invisibile, 280-281. Tradotto da Andrea Bonomi. Milano: Bompiani, 1969.
[18]Derrida, 75, 78.
[19]Derrida, 90-91.
[20]Jean-Luc Nancy cita l’Autoritratto di Johannes Gumpp (1646 ca., Uffizi, Firenze) dove sono tre i soggetti dipinti: il pittore stesso di spalle, nell’atto di guardarsi in uno specchio, che gli rimanda la sua immagine riflessa, mentre sta dipingendo un autoritratto. Due sono i volti che compaiono alla vista: quello dello specchio, il cui sguardo risponde all’invisibile cenno del pittore che si guarda, e quello del quadro, il cui sguardo si sposta di lato, incontrando piuttosto l’osservatore. Ma tra i due e lo spettatore, c’è in realtà un terzo (o un quarto): il pittore stesso di spalle con il suo volto invisibile, e «questa assenza non è nient’altro che la condizione nella quale il soggetto si rapporta a sé e così si somiglia…questa identità è il rinvio senza fine di uno sguardo su di sé ad uno sguardo fuori di sé e ad una esposizione di sé». Nancy, Jean-Luc. Le Regard du portrait. Paris: Éditions Galilée, 2000. Edizione italiana: Nancy, Jean-Luc e Raoul Kirchmayr, cur. Il ritratto e il suo sguardo, 47. Milano: Raffaello Cortina, 2002. Si veda la recensione di Baptist, Gabriella su www.kainos.it/Pages/recensione%20Nancy.html (ultima visita sito web: 03/07/2023).
[21]Nancy, 54, 56.
[22]Nancy, 72.
[23]Derrida, 92
[24]Derrida, 78.
[25]Derrida, 98-99.
[26]“Per mozzare la testa di Medusa dopo la sfida di Polidette, l’eroe aveva dovuto moltiplicare le tappe, e in tutte queste tappe la storia è, ogni volta, una storia dell’occhio. Perseo deve ricevere dalle Ninfe l’elmo di Ade, la Kunee che rende invisibili. Cercando le Ninfe, tuttavia, si reca dapprima presso le antenate, le Graie, sorelle delle Gorgoni, le quali non possiedono, tutte e tre, che un solo occhio e un solo dente. Una di loro veglia tenendo l’occhio sempre aperto e il dente pronto a divorare. Perseo le deruba proprio nel momento in cui al cambio della guardia, se così si può dire, l’occhio e il dente passano di mano in mano e, dunque, non appartengono a nessuno. Egli ruba una sorta di vigilanza senza soggetto. (E l’unico occhio si stacca ancora, circola tra i soggetti come un organo strumentale, una protesi feticizzata…)”. Derrida, 99-100. Anche Barthes, Roland ricorda l’Histoire de l’oeil di Bataille come la storia di un oggetto: dell’occhio e delle sue migrazioni verso altri oggetti, del suo passare di mano in mano, e, di conseguenza, di alludere ad usi diversi da quello del «vedere». In questo testo compaiono proprio due catene metaforiche – circolari, ovvero senza gerarchia: quella dell’occhio e quella del pianto, che Bataille incrocia tra loro con gusto surreale. Si veda, appunto, Barthes, Roland. “La metafora dell’occhio”. In Barthes, Roland, Gianfranco Marrone, cur., e Lidia Lonzi, cur. Saggi critici [Essais critiques]. Torino: Einaudi, 1972.
[27]“La disseminazione generalizza la teoria e la pratica dell’innesto senza corpo proprio o dello sbieco (biais) senza fronte”. Si veda Derrida, Jacques. “Hors livre. Préfaces”. In La dissémination. Paris: Seuil, 1972. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Silvano Petrosino, cur. e Marcella Odorici, cur. “Fuori libro”, 55. In La disseminazione. Milano: Jaca Book, 1989. Biais significa letteralmente obliquo, sbieco, verso e viene usato, ad esempio, nell’espressione «guardare di sbieco». Biais si usa anche per indicare la «via traversa» o la «scappatoia». Derrida ricorda ancora Mallarmé che «dipinge non la cosa, ma l’effetto che essa produce», «presentandocela di sbieco per offrircela di faccia»,«poiché vi è sempre, testualmente, solo la silhouette, si può opporre ad ogni concezione frontale del tema lo sbieco (bias) della scrittura mallarmiana, il bifax continuamente rimarcato del suo doppio gioco». Si veda anche Derrida, Jacques. “La double séance”. In La dissémination. Paris: Seuil, 1972. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Silvano Petrosino, cur. e Marcella Odorici, cur. “La doppia seduta”, 270, 273. In La disseminazione. Milano: Jaca Book, 1989. «L’idolo del tempio muore se è visto in piena luce, poiché in questo caso appare per quello che è: legno lavorato, metallo forgiato, pietra scolpita. Il dio vi resta visibile solo se lo sguardo si fa abbastanza casto da non arrivare a possederlo in carne ed ossa – in e come idolo». A tal riguardo, Marion, Jean-Luc. L’idole et la distance. Paris: Editions Grasset & Fasquelle, 1977. Edizione italiana: Marion, Jean-Luc e Adriano Dell’Asta, cur. L’idolo e la distanza, 41. Milano: Jaca Book, 1979. Derrida, La disseminazione, 367.
[28]Rilke, Rainer Maria. “Die achte Elegie”. In Duineser Elegien. Leipzig: Insel-Verlag, 1923. Edizione italiana: Rilke, Rainer Maria, Enrico De Portu, cur., e Igea De Portu, cur. “Ottava Elegia”, 50-53. In Elegie Duinesi. Torino: Einaudi, 1987.
[29]Freud, Sigmund. “Das Medusenhauptè” [1922]. In Gesammelte Werke. London: Imago Publishing Co., 1940. Edizione italiana: Freud, Sigmund e Cesare L. Musatti, cur. “La testa di Medusa”, 415. In Opere, vol. IX. Torino: Bollati Boringhieri, 1996.
Derrrida parla del legame tra pietra e fallo e di come per Freud, ciò che diventa pietra lo diventi perché davanti alla testa tagliata di Medusa. L’esibizione della sua testa mozzata ha una funzione apotropaica: ciò che suscita orrore in noi dovrà produrre lo stesso effetto anche sul nemico da cui ci dobbiamo difendere.
Per Derrida la castrazione sarebbe in opera da sempre. Il colpo diverrebbe il seme gettandolo. E la legge del taglio autorizzerebbe a smembrare il testo: “perdere la testa, non sapere più dove mettere la testa, questo è forse l’effetto della disseminazione”. Vedere ancora Derrida, Fuori libro, 64.
[30]Freud, Sigmund. “Das Unheimliche” [1919]. In Gesammelte Werke. London: Imago Publishing Co., 1940. Edizione italiana: Freud, Sigmund e Cesare L. Musatti, cur. “Il perturbante”. Tradotto da Silvano Daniele. In Opere, vol. IX. Torino: Bollati Boringhieri, 1996.
[31]Derrida, Memorie di cieco, 126, 131.
[32]Freud, 152.
[33]Derrida ricorda che le lacrime, sono spesso lacrime di donna e in Sproni, scrive a proposito di Nietzsche. «Nietzsche […] è il pensatore della gravidanza. Che egli loda tanto nella donna quanto nell’uomo. E siccome piangeva facilmente, e siccome gli è capitato di parlare del proprio pensiero come una donna incinta del proprio bambino, mi piace spesso immaginarlo mentre versa lacrime sul suo ventre». Si veda Derrida, Jacques. Eperons. Les styles de Nietzsche. Paris: Flammarion, 1976. Edizione italiana: Derrida, Jacques, e Stefano Agosti, cur. Sproni. Gli stili di Nietzsche, 63. Milano: Adelphi, 1991.
[34]Derrida, Memorie di cieco, 152.
[35]Dovolich, Claudia. “Derrida tra la chiusura della mimesis e il ritrarsi della metafora”, 132-162. In Segno, comunicazione, azione. Milano: FrancoAngeli, 1994. Si veda anche Dovolich, Claudia. “Derrida si interroga sul segno”, 83-102. In Guerrera, Francesca Brezzi. Hermes: Dagli dèi agli uomini. Roma: Armando Editore, 1989. Inoltre, si veda Dovolich Claudia. Derrida tra differenza e trascendentale, 264. Milano: FrancoAngeli, 1995.
[36]A tale proposito, nell’ambito della riflessione su tali temi, si ricorda come lo schema prospettico, che vige da Socrate ad Husserl, è da sempre stato lo schema classico della visione secondo cui l’occhio sarebbe in grado di vedere ogni cosa. Uno sguardo univoco che considera l’occhio una funzione di conoscenza. Questo schema viene messo in crisi dalla psicoanalisi, per cui cambia il punto di partenza, che non è più l’occhio, bensì lo sguardo entro cui si muovono gli occhi. Nel nuovo schema proposto dalla psicoanalisi, il soggetto della rappresentazione è in relazione con lo sguardo e tra di essi c’è l’immagine sia della veglia che del sonno perché, come sostiene Freud, si può vedere anche ad occhi chiusi, ossia durante il sonno. Lo sguardo è in relazione alla propria verità/al proprio vero, ovvero, si vede solo ciò che è in relazione al proprio desiderio inconscio. A seguito della relazione, del movimento complesso tra lo sguardo e il soggetto della raffigurazione, si forma il quadro, che si trova all’incrocio, al nodo tra i due. È lo sguardo ad inaugurare il movimento dell’occhio, e non, come si riteneva con la precedente visione prospettica, il contrario. È lo sguardo che «accende» e rende significante. Lacan, Jacques e Jacques-Alain Miller. Le quatre concepts fondamentaux de la psychoanalyse, Livre XI. Paris: Sueil, 1973. Edizione italiana: Lacan, Jacques, Jacques-Alain Miller e Antonio Di Ciaccia, cur. Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 104-105. Tradotto da Adele Succetti. Torino: Einaudi, 2003.
[37]Lo sguardo a noi si presenta solo nella forma di una strana contingenza, simbolica di ciò che troviamo all’orizzonte e come arresto della nostra esperienza […]. L’occhio e lo sguardo, questa è per noi la schisi in cui si manifesta la pulsione a livello del campo scopico. Lacan, 72.
[38]Ferrari, Federico. “L’eredità dell’avvenire. Riflessi di un’estetica spettrale”, 169. In Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine. Milano: Abscondita, 2003. Lo stesso Lacan aveva citato: Diderot, Denis. Lettres sur les aveugles. Genève: Droz, 1951. Edizione italiana: Diderot, Denis, e Brini M. Savorelli, cur. Lettera sui ciechi per coloro che vedono, 85. Scandicci: La Nuova Italia, 1999.
[39]Agosti, Stefano. “Colpo su colpo”, 25. In Derrida, Jacques, e Stefano Agosti, cur. Sproni. Gli stili di Nietzsche. Milano: Adelphi, 2011.
[40]Lo sguardo, come lo concepisce Sartre, è lo sguardo dal quale io sono sorpreso – sorpreso in quanto cambia tutte le prospettive, le linee di forza del mio mondo, in quanto lo ordina, dal punto di nulla in cui sono, in una sorta di reticolatura irradiata degli organismi. Luogo del rapporto fra me, soggetto nullificante, e ciò che mi circonda, lo sguardo avrebbe lì un privilegio tale da arrivare fino a farmi scotomizzare, a me che guardo, l’occhio di colui che mi guarda come oggetto. In quanto sono sotto lo sguardo, scrive Sartre, non vedo più l’occhio che mi guarda e, se vedo l’occhio, allora è lo sguardo che scompare. […] Lo sguardo si vede – precisamente quello sguardo di cui parla Sartre, quello sguardo che mi sorprende e che mi riduce a una qualche vergogna, poiché è questo il sentimento che egli delinea come il più accentuato. Questo sguardo che io incontro […] è, non già uno sguardo visto, ma uno sguardo da me immaginato nel campo dell’Altro. Se vi rifate al suo testo, vedrete che, lungi dal parlare dell’entrata in scena di questo sguardo come di qualcosa che concerne l’organo della vista, egli si rifà a un rumore di foglie improvvisamente udito mentre sono a caccia, a un passo sorto nel corridoio, e in che momento? – nel momento in cui egli stesso si è presentato nell’azione di guardare attraverso il buco di una serratura. Uno sguardo lo sorprende nella funzione di voyeur, lo sconcerta, lo sconvolge e lo riduce al sentimento della vergogna. Lo sguardo di cui si tratta è proprio presenza di altrui come tale. […] Non è forse chiaro che lo sguardo non interviene qui che nella misura in cui non è il soggetto annientante, correlativo del mondo dell’oggettività, a sentirsi sorpreso, ma il soggetto che si sostiene in una funzione di desiderio? Non è forse proprio perché il desiderio si instaura qui nell’ambito della veditura, che possiamo eluderlo? Ancora in Lacan, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi, 82-83
[41]Derrida, Memorie di cieco, 91.
[42]Il riferimento è qui alla fiaba orientale raccontata da Erodoto all’inizio del cosiddetto logos lidio. Gige, guardia del corpo del re lidio Candaule, fu persuaso da quest’ultimo a spiare da dietro la porta della camera da letto, – vedendo senza essere visto – la bellezza di sua moglie. Quest’ultima, accortasi dell’inganno, costrinse Gige ad uccidere Candaule. Gige divenne così re della Lidia (716-678 a. C.) impossessandosi del trono con una rivolta di palazzo e mediante un anello che lo rendeva invisibile. Vedere Rosati, Giuseppe. Scrittori di Grecia. Il periodo attico, vol. II, 674-678. Firenze: Sansoni Editore, 1992.
[43]Ferrari, 164. A proposito di questo argomento, si veda anche Steinmetz, Rudy. “Spectres de l’esthétique”, 43-59. In Roelens, Nathalie. Jacques Derrida et l’esthétique. Paris: L’Harmattan, 2000. Si veda, inoltre, Fried, Michael. “Entre deux réalismes: sur quelques dessins autoportraits de Fantin-Latour”, 493-505. In Derrida, Jacques e Marie-Louise Mallet, cur. Le passage des frontières. Autour du travail de Jacques Derrida. Paris: Galilée, 1994.
[44]Derrida, Jacques. Spectres de Marx. Paris: Galilée, 1993. Edizione italiana: Derrida, Jacques, e Gaetano Chiurazzi, cur. Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, 73. Milano: Raffaello Cortina, 1994. Ancora, a proposito di eredità: “ereditare non consiste nel ricevere un bene o un capitale che sarebbe già e per sempre in un luogo…L’eredità implica la decisione, la responsabilità, la risposta, e di conseguenza la selezione critica, la scelta; c’è sempre scelta, che lo si voglia o no, che sia o no cosciente”. Vedere Derrida, Delle eredità – e del ritmo, 75-76. In Derrida, Jacques e Bernard Stiegler. Echographies de la télévision. Paris: Editions Galilée/Institut national de l’audiovisuel, Paris, 1996. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Bernard Stiegler, Gabriele Piana, cur. e L. Chiesa, cur. Ecografie della televisione. Milano: Raffaello Cortina, 1997.
[45]Claudel, Paul. Positions et propositions, 46, I. Paris: Gallimard, 1944. Citato in Derrida, La disseminazione, 85.
[46]Il riferimento è qui ad un suono inudibile a cui si riferisce il koan citato da M. Heidegger nel corso del Seminario Die Kunst und das Denken del 18 maggio 1958 tenuto all’Università di Freiburg che ebbe come principale interlocutore H. Sh. Hisamatsu: «Vorrei concludere con un koan che era il preferito del maestro Hakuin: (alzando la mano). Ascolta il suono del clap di una mano sola (…)». Vedere Heidegger, Martin e Hisamatsu Shinichi. “Die Kunst und das Denken”, 211-215. In Heidegger, Martin, e Hartmut Buchner, cur. Japan und Heidegger: Gedenkschrift der Stadt Messkirch zum Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1989. Su questo argomento si veda: Tezuka, Tomio e Leonardo Vittorio Arena, cur. Un’ora con Heidegger. Oriente e Occidente [Haidega to no ichijikan], 65-66. Milano-Udine: Mimesis, 2021. Sull’argomento si veda anche: Proietti, Maria Letizia e Marcella D’Abbiero, cur. “L’arte e il pensiero dopo Freud: Martin Heidegger con Jacques Lacan”, 159-176. In Desiderio e Filosofia. Milano: Guerini, 2003. Proietti, Maria Letizia. La cosa poetica in M. Heidegger. Roma: Bulzoni, 1985. Vedere, inoltre, Proietti, Maria Letizia. “La questione dell’immaginazione tra coscienza e inconscio”. In Recent Receptions of Freud on Both Sides of Atlantic. New York: P. Lang, 1991.
Bibliografia
Agosti, Stefano. “Colpo su colpo”. In Derrida, Jacques, e Stefano Agosti, cur. Sproni. Gli stili di Nietzsche. Milano: Adelphi, 2011.
Argan, Giulio Carlo. “Ho una malattia, io vedo il linguaggio”. In Barthes, Roland, e Achille Bonito Oliva, cur. Intermezzo. Milano: Skira, 2004.
Baddeley, Alan. La memoria umana. Teoria e pratica. Tradotto da Marco Ricucci. Bologna: Il Mulino, 1995.
Bartlett, Frederic C. Remembering. A study in experimental and Social Psychology. Cambridge: Cambridge University Press, 1932.
Barthes, Roland. La Chambre Claire: Note sur la photographie. Paris: Gallimard – Le Seuil, 1980. Edizione italiana: Barthes, Roland e Remo Guidieri, cur. La camera chiara. Nota sulla fotografia. Torino: Einaudi, 2003.
Barthes, Roland, e Achille Bonito Oliva, cur. Intermezzo. Milano: Skira, 2004.
Barthes, Roland. “La metafora dell’occhio”. In Barthes, Roland, Gianfranco Marrone, cur., e Lidia Lonzi, cur. Saggi critici [Essais critiques]. Torino: Einaudi, 1972.
Brandimonte, Maria A. Psicologia della memoria. Roma: Carocci, 2004.
D’Ambrosio, Antonio, e Pasquale Supino. La sindrome dei falsi ricordi. Cosa sono i falsi ricordi, come individuarli e ridurne il rischio. Milano: FrancoAngeli, 2014.
Claudel, Paul. Positions et propositions. Paris: Gallimard, 1944.
Derrida, Jacques e Bernard Stiegler. Echographies de la télévision. Paris: Editions Galilée/Institut national de l’audiovisuel, Paris, 1996. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Bernard Stiegler, Gabriele Piana, cur. e L. Chiesa, cur. Ecografie della televisione. Milano: Raffaello Cortina, 1997.
Derrida, Jacques. Eperons. Les styles de Nietzsche. Paris: Flammarion, 1976. Edizione italiana: Derrida, Jacques, e Stefano Agosti, cur. Sproni. Gli stili di Nietzsche. Milano: Adelphi, 1991.
Derrida, Jacques. Force et signification. In L’écriture et la différence. Paris:Seuil, 1967. Edizione italiana: Derrida, Jacques e Gianni Pozzi, cur. Forza e significazione. In La scrittura e la differenza. Milano: Jaca Book, 1984 [Bibliografia secondaria].
Derrida, Jacques. “Hors livre. Préfaces”. In La dissémination. Paris: Seuil, 1972. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Silvano Petrosino, cur. e Marcella Odorici, cur. “Fuori libro”. In La disseminazione. Milano: Jaca Book, 1989.
Derrida, Jacques. “La double séance ». In La dissémination. Paris: Seuil, 1972. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Silvano Petrosino, cur. e Marcella Odorici, cur. “La doppia seduta”. In La disseminazione. Milano: Jaca Book, 1989.
Derrida, Jacques. «Le Retrait de La Métaphore». La revue PO&SIE. Belin/Humensis Paris, 1978. Derrida, Jacques. «Le Retrait de La Métaphore». The Phenomenology of Man and of the Human Condition. Springer Netherlands, 1983. doi:10.1007/978-94-009-6969-8_19. Anche in Derrida, Jacques. Psyché. Paris: Galilée, 1998. Anche in Derrida, Jacques. «Il ritrarsi della metafora». Tradotto da Maurizio Ferraris. Aut Aut, 220-221, La Nuova Italia Firenze, 1987.
Derrida, Jacques. Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines. Paris: Editions de la réunion des Musées Nationaux, 1990. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., e Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine. Milano: Abscondita, 2003.
Derrida, Jacques. Mémoires pour Paul de Man. Paris: Galilée, 1988. Edizione italiana: Derrida, Jacques, Giovanna Borradori, cur. ed Enzo Costa, cur. Memorie per Paul De Man. Saggio sull’autobiografia. Milano: Jaca Book, 1995.
Derrida, Jacques. Spectres de Marx. Paris: Galilée, 1993. Edizione italiana: Derrida, Jacques, e Gaetano Chiurazzi, cur. Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale. Milano: Raffaello Cortina, 1994.
Diderot, Denis. Lettres sur les aveugles. Genève: Droz, 1951. Edizione italiana: Diderot, Denis, e Brini M. Savorelli, cur. Lettera sui ciechi per coloro che vedono. Scandicci: La Nuova Italia, 1999.
Dovolich, Claudia. “Derrida si interroga sul segno”. In Guerrera, Francesca Brezzi. Hermes: Dagli dèi agli uomini. Roma: Armando Editore, 1989.
Dovolich, Claudia. “Derrida tra la chiusura della mimesis e il ritrarsi della metafora”. In Segno, comunicazione, azione. Milano: FrancoAngeli, 1994.
Dovolich Claudia. Derrida tra differenza e trascendentale. Milano: FrancoAngeli, 1995.
De Man, Paul. Blindness & Insight/Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism. New York: Oxford University Press, 1971. Edizione italiana: De Man, Paul, ed Eduardo Saccone, cur. Cecità e visione/Linguaggio letterario e critica contemporanea. Napoli: Liguori, 1975.
Ferrari, Federico. “L’eredità dell’avvenire. Riflessi di un’estetica spettrale”. In Derrida, Jacques, Alfonso Cariolato, cur., Federico Ferrari, cur. Memorie di cieco. L’autoritratto e altre rovine. Milano: Abscondita, 2003.
Freud, Sigmund. “Das Medusenhauptè” [1922]. In Gesammelte Werke. London: Imago Publishing Co., 1940. Edizione italiana: Freud, Sigmund e Cesare L. Musatti, cur. “La testa di Medusa”. In Opere, vol. IX. Torino: Bollati Boringhieri, 1996.
Freud, Sigmund. “Das Unheimliche” [1919]. In Gesammelte Werke. London: Imago Publishing Co., 1940. Edizione italiana: Freud, Sigmund e Cesare L. Musatti, cur. “Il perturbante”. Tradotto da Silvano Daniele. In Opere, vol. IX. Torino: Bollati Boringhieri, 1996.
Fried, Michael. “Entre deux réalismes: sur quelques dessins autoportraits de Fantin-Latour”. In Derrida, Jacques e Marie-Louise Mallet, cur. Le passage des frontières. Autour du travail de Jacques Derrida. Paris: Galilée, 1994.
Heidegger, Martin e Hisamatsu Shinichi. “Die Kunst und das Denken”. In Heidegger, Martin, e Hartmut Buchner, cur. Japan und Heidegger: Gedenkschrift der Stadt Messkirch zum Hundertsten Geburtstag Martin Heideggers. Sigmaringen: J. Thorbecke, 1989.
Lacan, Jacques e Jacques-Alain Miller. Le quatre concepts fondamentaux de la psychoanalyse, Livre XI. Paris: Sueil, 1973. Edizione italiana: Lacan, Jacques, Jacques-Alain Miller e Antonio Di Ciaccia, cur. Il Seminario, Libro XI, I quattro concetti fondamentali della psicoanalisi. Tradotto da Adele Succetti. Torino: Einaudi, 2003.
Marion, Jean-Luc. L’idole et la distance. Paris: Editions Grasset & Fasquelle, 1977. Edizione italiana: Marion, Jean-Luc e Adriano Dell’Asta, cur. L’idolo e la distanza. Milano: Jaca Book, 1979.
Merleau-Ponty, Maurice. Le visible et l’invisible. Paris: Éditions Gallimard, 1964. Edizione italiana: Merleau-Ponty, Maurice,Mauro Carbone, cur., e Claude Lefort, cur. Il visibile e l’invisibile. Tradotto da Andrea Bonomi. Milano: Bompiani, 1969.
Mottola Colban, Luciana. “Intervista di J. Derrida”. In Il giornale dell’arte, 82. Ottobre 1990.
Nancy, Jean-Luc. Le Regard du portrait. Paris: Éditions Galilée, 2000. Edizione italiana: Nancy, Jean-Luc e Raoul Kirchmayr, cur. Il ritratto e il suo sguardo. Milano: Raffaello Cortina, 2002.
Panofsky, Erwin. Studi di iconologia. I temi umanistici dell’arte del Rinascimento. Tradotto da Renato Pedio. Torino: Einaudi, 1975.
Plinio Il Vecchio, Naturalis historia, XXXV.
Proietti, Maria Letizia e Marcella D’Abbiero, cur. “L’arte e il pensiero dopo Freud: Martin Heidegger con Jacques Lacan”. In Desiderio e Filosofia. Milano: Guerini, 2003.
Proietti, Maria Letizia. La cosa poetica in M. Heidegger. Roma: Bulzoni, 1985.
Proietti, Maria Letizia. “La questione dell’immaginazione tra coscienza e inconscio”. In Recent Receptions of Freud on Both Sides of Atlantic. New York: P. Lang, 1991.
Proietti, Maria Letizia. “La questione dell’immaginazione tra coscienza e inconscio: per un altro orizzonte critico”. In Proietti, Maria Letizia, Maria Dalai Emiliani e Stefano Marconi, cur. Scritti e immagini in onore di Corrado Maltese. Roma: Quasar, 1997.
Rilke, Rainer Maria. “Die achte Elegie”. In Duineser Elegien. Leipzig: Insel-Verlag, 1923. Edizione italiana: Rilke, Rainer Maria, Enrico De Portu, cur., e Igea De Portu, cur. “Ottava Elegia”. In Elegie duinesi. Torino: Einaudi, 1987.
Rosati, Giuseppe. Scrittori di Grecia. Il periodo attico, vol. II. Firenze: Sansoni Editore, 1992.
Steinmetz, Rudy. “Spectres de l’esthétique”. In Roelens, Nathalie. Jacques Derrida et l’esthétique. Paris: L’Harmattan, 2000.
Tezuka, Tomio e Leonardo Vittorio Arena, cur. Un’ora con Heidegger. Oriente e Occidente [Haidega to no ichijikan]. Milano-Udine: Mimesis, 2021.
Wittgenstein, Ludwig e M. Caleo, cur. Il Tractatus logico-Philosophicus di L. Wittgenstein. Decifrato [Logisch-philosophische Abhaudlung]. Lancusi (Sa): Elea Press, 1996.
Sitografia
Angeleri, Laura. La figura moderna dell’autore, in www.rescogitans.it/ita/Biblioteca/Angeleri/Barthes.htm (link non più attivo al 03/07/2023).
Baptist, Gabriella su www.kainos.it/Pages/recensione%20Nancy.html (ultima visita sito web il 03/07/2023).