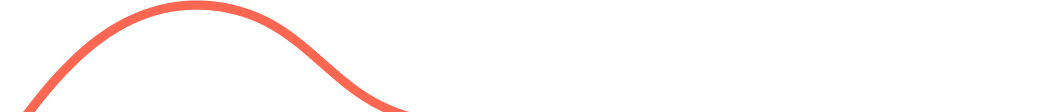Davide Orlandi, Universidad de Granada – ORCID ID: 0009-0007-2102-625X
E-mail: orlandi.dav@tiscali.it
doi: 10.14672/VDS20242PR7
(https://doi.org/10.14672/VDS20242PR7)
Abstract
Molteplici ambiti del sapere umano mettono in primo piano la questione dell’identità.
In relazione agli sviluppi tecnologici raggiunti e prospettati, ci chiediamo quale sia l’identità dell’uomo e come si possa rispondere a tale interrogativo, su un piano filosofico, nella contemporaneità. Dunque, ci chiediamo: cos’è che fa dell’uomo un uomo? La domanda si ripropone con un’urgenza che scaturisce dalla necessità di rispondere in una modalità innovativa, tanto quanto le innovazioni che l’hanno riproposta. Innovazione interrogativa alla quale è immanente una declinazione plurale della risposta e che implica un superamento imprescindibile della risoluzione unilaterale e monotematica. Ritorna, sul piano filosofico, l’inaggirabile questione della natura umana. Essa non risiede in maniera univoca ed essenziale in un’unica nota caratterizzante.
A qualificare come obsoleto il tentativo di definire l’identità umana in maniera monolitica ed a moltiplicare la complessità della questione è la situazione politico-culturale contemporanea, caratterizzata dalla cospicua compresenza di diversi gruppi etnici. Tale presenza connota culturalmente le società come pluralistiche. Ciò che, maggiormente, impegna il pensiero filosofico è proprio la questione dell’identità umana contestualizzata nello scenario multiculturale contemporaneo.
In tale prospettiva nasce l’esigenza di un ripensamento dell’identità dell’io in parametri nuovi per favorire la nascita di un linguaggio interculturale.
Va promossa una concezione di essa come spazio che consenta la condivisione delle differenze, nell’ottica di un arricchimento conseguente.
Keywords: identità, relazione, multiculturalismo, cultura, pluralismo.
Many areas of human knowledge foreground the question of identity.
In relation to the technological developments achieved and envisaged, we ask ourselves what the identity of man is and how this question can be answered, on a philosophical level, in contemporary times. So, we ask ourselves: what is it that makes a man a man? The question comes up again with an urgency that stems from the need to answer it in a way that is as innovative as the innovations that put it forward. Questioning innovation to which a plural declination of the answer is immanent, and which implies an unavoidable overcoming of the unilateral and monothematic resolution. The inescapable question of human nature returns on a philosophical level. It does not reside unambiguously and essentially in a single characterising note. Qualifying the attempt to define human identity in a monolithic manner as obsolete and multiplying the complexity of the issue is the contemporary political and cultural situation, characterised by the conspicuous coexistence of different ethnic groups. This presence culturally connotes societies as pluralistic. What most engages philosophical thought is precisely the question of human identity contextualised in the contemporary multicultural scenario.
In this perspective, the need arises for a rethinking of the identity of the self in new parameters to foster the emergence of an intercultural language.
A conception of it as a space that allows differences to be shared, with a view to consequent enrichment, must be promoted.
Keywords: identity, relationship, multiculturalism, culture, pluralism.
Introduzione
Molteplici ambiti del sapere umano mettono in primo piano la questione dell’identità. Lo sviluppo tecnologico ha condotto l’uomo alla possibilità di vedersi clonato in robot che ripetono, simulano i nostri gesti sostituendoci in maniera efficace in molte azioni. Le scienze mediche, con la cosiddetta “rivoluzione pro-creativa”, sembrano aver messo in crisi la modalità di comprendere il tempo dell’origine, la creazione della vita. Si pensi ad esempio all’utilizzo della diagnosi del preimpianto: si applicano dei test genetici sugli embrioni al fine di decidere il loro impianto. L’applicazione di questa pratica rende precario, “non più definibile con chiarezza il confine concettuale tra il prevenire la nascita di un bambino gravemente malato e la decisione eugenetica di migliorarne il patrimonio ereditario”[1].
Sulla scia delle osservazioni dell’autore di Il futuro della natura umana non intendiamo tacerne l’importanza in ambito diagnostico, ma, allo stesso tempo, consideriamo innegabili le implicazioni che essa induce sul piano etico.
Il pensatore tedesco si chiede infatti se sia compatibile con la dignità della vita umana essere generato con riserva, “essere giudicato degno di vita e di sviluppo in base all’esito di un test genetico”[2].
Quest’interrogativo rimanda alla questione fondamentale del valore da attribuire alla vita della specie umana. Quale significato vogliamo dare alla vita umana?
Habermas teme che la genetica liberale, affidandosi alle opzioni interessate dei genitori, nel caso dell’applicazione della diagnosi del preimpianto, sfoci in un’eugenetica. Il medesimo timore appartiene anche ad Hans Jonas, altro pensatore attento e preoccupato delle sterminate possibilità dell’uomo della tecnica.
L’autore di Il Principio responsabilità, Un’etica per la civiltà tecnologica esprime, con preoccupazione, in diversi luoghi e modi, i rischi dello sviluppo della genetica.
Il rischio principale sarebbe rintracciabile “[…] nell’eventualità che l’uomo, sostituendosi a Dio, possa un giorno arrivare a manipolare la sua stessa costituzione genetica per i fini più disparati o anche prospettiva non meno inquietante, per produrre uomini migliori”[3].
Timore quanto mai realistico. Jonas presagisce una situazione che le biotecnologie hanno consentito di ipotizzare ovvero la modificazione del patrimonio genetico. Infatti, gli sviluppi nel campo della biologia hanno condotto alla possibilità d’immaginare una modificazione dell’immodificabile: il DNA, caratteristica peculiare della propria identità biologica.
In relazione agli sviluppi tecnologici raggiunti e prospettati, ci chiediamo quale sia l’identità dell’uomo e come si possa rispondere a tale interrogativo, su un piano filosofico, nella contemporaneità[4]. L’identità dell’uomo come identità biologica, se le modificazioni del DNA non si limitassero alla cura delle malattie genetiche, non potrebbe più equivalere a ciò che siamo, ma equivarrebbe “a ciò che ci siamo dati”, ciò che hanno scelto che fossimo[5]. Dunque, ci chiediamo: cos’è che fa dell’uomo un uomo?[6] La domanda si ripropone con un’urgenza che scaturisce dalla necessità di rispondere in una modalità innovativa, tanto quanto le innovazioni che l’hanno riproposta.
Innovazione interrogativa alla quale è immanente una declinazione plurale della risposta e che implica un superamento imprescindibile della risoluzione unilaterale e monotematica. Ritorna, sul piano filosofico, l’inaggirabile questione della natura umana. Essa non risiede in maniera univoca ed essenziale in un’unica nota caratterizzante.
Il linguaggio articolato, ad esempio, non può essere più considerato una cifra distintiva dell’umano perché si è scoperto che diversi animali emettono dei suoni aventi significatività sul piano della comunicazione[7]. Nemmeno l’intelligenza[8] né la capacità di pensare, il possesso della ragione[9] possono qualificare in maniera univoca l’identità dell’uomo perché queste possibilità vengono, se non ricreate, quantomeno simulate dai robots. Solo l’empatia, come ha messo in luce Eugenio Mazzarella, non sarebbe riproducibile nemmeno in via di simulazione e risulterebbe, per tale motivo, l’elemento distintivo dell’uomo rispetto al suo “clone elettronico”[10].
A qualificare come obsoleto il tentativo di definire l’identità umana in maniera monolitica ed a moltiplicare la complessità della questione è la situazione politico-culturale contemporanea, caratterizzata dalla cospicua compresenza di diversi gruppi etnici. Tale presenza connota culturalmente le società come pluralistiche.
Ciò che, maggiormente, impegna il pensiero filosofico è proprio la questione dell’identità umana contestualizzata nello scenario multiculturale contemporaneo.
In tale prospettiva nasce l’esigenza di un ripensamento dell’identità dell’io in parametri nuovi per favorire la nascita di un linguaggio interculturale.
″Un linguaggio″ che non si limiti alla giustapposizione delle diverse realtà culturali, che non dia vita, parafrasando Maria Laura Lanzillo, ad una società multiculturale a mosaico, nella quale ogni comunità culturale è una realtà a sé stante, che non interagisce con l’esterno, limitandosi a vivere come una sorta di monade.
La causa principale della configurazione della società multiculturale a mosaico, seguendo le considerazioni dell’autrice di Multiculturalismo, è l’incapacità di affrontare in maniera adeguata la questione della cultura[11].
Inadeguatezza intesa come limite del pensiero, mancanza di un linguaggio, che consenta di non limitarsi al multiculturalismo come constatazione delle differenti culture[12], ma che possa realizzare l’effettiva interrelazione.
La nuova modalità di intendere ed esprimere l’identità dell’io nel contesto multiculturale, che qui si intende delineare, vorremmo fosse un monito a promuovere nuovi modi di pensare, che siano conformi alla contemporanea socialità, che siano quindi ″interculturali″.
In tale prospettiva d’intenti, si vuole mostrare l’inadeguatezza delle definizioni ‘ingabbianti dell’identità’ e la mancanza di pertinenza, nella prospettiva attuale, di una certa modalità di argomentare e definire, una maniera statica di pensare più che obsoleta. Ci riferiamo principalmente alla concezione dell’identità dell’io, espressa in termini esclusivi di un elemento portatore di specificità-singolarità, che funge da possibile punto di riferimento per la superiorità, il dominio di una cultura sull’altra.
A questa concezione definitiva, chiusa, si vorrebbe contrapporre e promuovere un’idea dell’identità, che possa costituirsi come criterio-guida per riconoscere la complessità delle identità individuali e collettive, ripensandole sul piano interculturale. Ripensare l’identità in modo fluido e dinamico intende essere il presupposto teorico per la comunicazione tra le differenti culture, che costellano la variegata società odierna. Essa si deve configurare come un medium per l’ascolto, l’accoglimento, la comprensione e la condivisione delle altre identità culturali.
Nella contemporaneità, infatti, l’identità sfugge ad ogni tentativo di definizione che sia valido in maniera universale ed assoluta. È così difficile determinarla in maniera univoca, perché essa non è più esprimibile con una definizione.
Occorre costatare che non è più una categoria di riconoscimento dell’io, ma è un elemento mutevole, fluido che è in continuo divenire nella dimensione dell’ascolto comunicativo con le altre identità[13]. Va promossa una concezione di essa come spazio che consenta la condivisione delle differenze, nell’ottica di un arricchimento conseguente.
L’intenzionalità teorica qui sottesa è quella di superare l’orizzonte concettuale definitivo dell’identità dell’io di matrice cartesiana, contestualizzando la problematica nello scenario multiculturale della contemporaneità.
Rivolgendo lo sguardo alla storia della filosofia, non tanto lontana, pensiamo agli anni Settanta del 900, ci si rende conto che, forse, tali intenzioni non sono affatto peregrine. La filosofia francese, dopo lo strutturalismo, rappresentata dal pensiero di Sartre, Foucault Derrida, Deleuze, Lévinas, Barthes, Lyotard, costituisce un ″campo di battaglia″ intorno al soggetto cartesianamente inteso.
L’idea che accomuna questi pensatori è quella di “aprire delle faglie” dalle quali far riaffiorare un soggetto, che non sia più un soggetto cartesiano, “che pensa e dunque è”, un soggetto che non sia più fondamento e principio, ma libertà[14].
Muore il soggetto, nasce la soggettività! Viene confutata la modalità di intendere l’identità umana che fa esclusivo riferimento, sulla scia di Cartesio, al possesso della ragione ed all’esercizio di questa nel pensare. L’emblema di questa contestazione del soggetto cartesianamente inteso e della delineazione della nascita di un nuovo soggetto inteso come soggettività è l’immagine letteraria del soggetto vuoto di Foucault, di un soggetto senza identità[15].
I filosofi francesi del post-strutturalismo hanno cercato di dare voce ad un pensiero libero[16] ad una modalità di ″pensare senza ringhiera″, prendendo in prestito un’espressione di Hanna Arendt.
Una modalità di pensare che fosse mobile, dinamica, così come lo era il soggetto, l’identità dell’io e la filosofia stessa, come sapere che racconta la storia di questa fluidità. In questa costruzione concettuale, di matrice francese, volta alla messa in crisi del soggetto cartesianamente inteso, che promuove un’idea di io mai definitivamente risolta, la filosofia di Paul Ricoeur assume un ruolo di grande rilievo. L’autore di Sé come un altro, crea una filosofia del sé, della persona contrapponendola alla visione logica e solipsistica del cogito cartesiano.
La filosofia di Ricoeur rappresenta uno degli itinerari analitici individuati perché consente di trarre alcune indicazioni funzionali al raggiungimento di una concezione dell’identità come prospettiva fluida e dinamica.
Irrinunciabilità e separatezza
I flussi migratori, le dimensioni globali dell’economia e dei mercati, le tecnologie moderne della comunicazione[17] delineano uno scenario contemporaneo in cui l’identità si configura come una questione complessa.
La riflessione sul processo identitario rimanda a due elementi imprescindibili: l’irrinunciabilità e la separatezza[18]. L’irrinunciabilità dell’identità e, congiuntamente, la sua complessità, scaturisce “dall’incompletezza biologica”. L’identità, nella sua forma culturale, rappresenterebbe perciò una “faccenda da non procrastinare” perché fungerebbe da risposta alle lacune che segnano la biologia dell’essere umano[19]. È importante chiarire, prima di procedere oltre, che la cultura non assume nell’intento di questo articolo il ruolo di paradigma definitorio, sostitutivo della natura.
La necessità della declinazione plurale è diffusamente e chiaramente messa in evidenza da molteplici studi di antropologia culturale. Richiamiamo alla memoria, a titolo esemplificativo, le considerazioni dello studioso Clifford Geertz:
La cultura, non completa gli esseri umani, in quanto animali incompleti, ma si tratta di forme di cultura particolari che entrano in gioco nella costruzione dell’identità. Non esiste una natura dell’uomo che lo possa definire, l’uomo diventa tale assumendo subito sembianze particolari, forgiate in qualche luogo sociale, in qualche ambiente culturale […]si tratta di una cornice all’interno della quale, ogni zona del mondo è un conglomerato di differenze profonde, particolarità e stranezze[20].
Nelle luci e nelle ombre, negli universi simbolici e nelle discontinuità di cui la cultura è portatrice risiederebbe la formazione delle identità. Nella visione dell’antropologo statunitense, la cultura va intesa, quindi, come un orizzonte di inclusione della molteplicità di valori, credenze e significati che gli individui elaborano. Le argomentazioni di Geertz dedicano infatti, ampio spazio alla riflessione sulla dimensione simbolica e mettono in luce il ruolo attivo degli individui nella creazione dei numerosi sistemi di significato che costellano una cultura:
L’idea di cultura che io prescelgo è essenzialmente di tipo semiotico. Convinto come, Max Weber, che l’uomo sia un animale sospeso entro reti di significato che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura sia costituita da queste reti e che quindi la sua analisi non debba essere una scienza sperimentale in ricerca delle leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato. Quel che cerco è una spiegazione[21].
La configurazione particolare, plurale semantica e semiotica della cultura, intorno alla quale diversi studiosi si sono soffermati, rappresenta in questo lavoro un punto di riferimento essenziale per poter mettere a tema la questione dell’identità in un mondo multiculturale.
L’irrinunciabilità[22] scaturisce anche dall’inevitabile confronto con le identità altre che attraversano il variegato scenario multiculturale contemporaneo.
Viviamo nell’epoca che ha dimezzato gli spazi ed i tempi: “i flussi globali sono sempre più rapidi e trasportano persone, idee, immagini, da un capo all’altro del mondo, connettendo in termini quasi reali comunità distanti e diverse tra loro”[23]. Nello slittamento d’attenzione “dal concetto di essere identici a sé stessi a quello di condividere un’identità con altri” (in particolare laddove quest’alterità si configura in termini di eticità, tradizioni, condivisione culturale), come ci suggerisce il filosofo ed economista angloindiano Amartya Sen, la questione diviene ancor più impervia.
Richiamiamo alla memoria un aneddoto, raccontato nel saggio Reason before Identity[24], che mostra una curiosa situazione in cui Sen si è trovato afare i conti con la complessità e irrinunciabilità dell’identità:
Qualche anno fa mentre ritornavo in Inghilterra da un breve viaggio all’estero (all’epoca ero direttore del Trinity College di Cambridge) il funzionario dell’immigrazione all’aeroporto, dopo aver accuratamente controllato il mio passaporto indiano, mi pose un quesito filosofico di una certa complessità. Osservando il mio indirizzo sul formulario per l’ufficio immigrazione, (residenza del direttore del Trinity College, Cambridge), mi chiese se il direttore, di cui ero probabilmente ospite fosse un mio amico. Dovetti fermarmi a pensare, non ero del tutto sicuro di poter affermare di essere amico di me stesso. Dopo aver riflettuto, arrivai alla conclusione che la risposta doveva essere sì. Dal momento che tutte queste elucubrazioni avevano richiesto del tempo, il funzionario dell’immigrazione volle sapere precisamente per quale motivo stessi esitando, e più nello specifico, se la mia permanenza in Gran Bretagna fosse viziata da qualche irregolarità. La questione pratica si risolse, ma la conversazione servì a ricordarmi, se mai ce ne fosse stato bisogno, che l’identità può essere una faccenda complicata[25].
L’irrinunciabilità identitaria, che si esplica come necessità di identificazione, di affiliazione ad un gruppo culturale, religioso o politico, è stata spesso associata ad un’esigenza di dominio e considerata come generatrice di conflitti. Proprio Sen in Identità e violenza ha affrontato l’implicazione della violenza nel processo identitario e ha delineato l’approccio plurale da adottare per potersi affrancare dall’implicazione del conflitto. L’itinerario concettuale, che qui Sen svolge, muove dalla presa di coscienza dei tratti che attraversano il mondo contemporaneo, qualificandolo: “la caoticità”, “la preoccupazione” e la “spaventosità”. Diversi sono gli elementi che concorrono nella costituzione di una siffatta immagine del mondo, primi fra tutti: gli avvenimenti violenti e le atrocità degli ultimi anni. Questi avrebbero, secondo il parere dell’economista una causa concettuale scatenante: la classificazione degli individui in due categorie esclusive: civiltà-cultura e religione. Questa convinzione attraversa anche un altro suo lavoro, Identità, povertà e diritti umani, in cui l’autore afferma che:
La politica del confronto globale viene spesso considerata come un corollario delle divisioni religiose o culturali. Anzi il mondo viene sempre più considerato, anche se solo implicitamente, come una federazione di religioni e civiltà, ignorando di conseguenza tutti gli altri modi in cui le persone percepiscono sé stesse. […]. Proprio in questo contesto, in cui si coltiva “un senso di inevitabilità a proposito di una presunta unica- e spesso belligerante- identità che ci caratterizzerebbe, la violenza trova spazio. Le stesse speranze di buone relazioni tra gli esseri umani vengono intese come amicizie tra civiltà, dialogo tra gruppi religiosi o comunità diverse, ignorando i tantissimi modi diversi di rapportarsi delle persone[26].
Sen affronta questo tema del disconoscimento della natura plurale delle nostre identità anche in Identità e violenza in cui sostiene che:
la stessa persona può essere, senza la minima contraddizione di cittadinanza, americana, di origine caraibica, con ascendenze africane, cristiane, progressista, donna vegetariana, maratoneta, storica, insegnante, romanziera, femminista, eterosessuale, sostenitrice dei diritti di gay e delle lesbiche, amante del teatro, militante, ambientalista appassionata di tennis, musicista jazz e profondamente convinta che esistano esseri intelligenti nello spazio con cui dobbiamo cercare di comunicarla più presto[27].
Considerare gli abitanti del pianeta come appartenenti ad una cultura o ad una religione significa oggettivare e staticizzare l’umano negando il diritto di scegliere la propria identità di volta in volta. Un approccio siffatto inficerebbe, nell’ottica di Sen i progressi per la pace, costituirebbe una decisiva fonte di conflitto nel mondo contemporaneo e sarebbe un modo “per miniaturizzare gli esseri umani e non capire nessuno al mondo”.
La debolezza concettuale di quest’irrinunciabile incasellamento in due principali comparti si evince, con chiarezza, dall’erronea considerazione della religione e della cultura. Queste non possono essere considerate come comparti omogenei, circoscritti e singolari, che fungerebbero da unici elementi determinanti le nostre identità. Soprattutto la cultura, scrive Sen, non è “un attributo omogeneo perché possono esistere diverse variazioni all’interno dello stesso panorama culturale”[28]. Essa, inoltre, non è immobile: ogni tentativo di definizione essenziale le è profondamente estraneo. La sua interazione con altri elementi determinanti l’agire sociale è forte e non può essere circoscritta. L’esito di queste riflessioni è la delineazione dell’approccio plurale che Sen suggerisce come atteggiamento proficuo nei confronti delle tematiche identitarie. Esso richiede come presupposti: il riconoscimento della pluralità delle affiliazioni, del ruolo delle scelte razionali e dell’importanza della libertà.
L’associazione di irrinunciabilità e violenza viene indagata anche dalle analisi antropologiche di un’altra voce del pensiero contemporaneo, che smantella il concetto d’identità tout court ed invita ad andare oltre la vecchia logica definitoria per poter cogliere la multidimensionalità della questione[29].
In Contro l’identità, Francesco Remotti promuove, infatti, una presa di coscienza della pericolosità del valore e della rivendicazione identitaria. Il testo prende avvio dalla fascinosa contrapposizione tra la fissità ed il divenire espressa con l’immagine degli oggetti della natura “che rimangono”, detti perciò “di struttura” e i fenomeni naturali che “fluiscono” in continuo movimento come le onde del mare. Queste metafore servono all’autore per mettere in posizione specularmente opposta: il modo,
a parer suo, inefficace e fuorviante di rappresentare l’identità e il modo proficuo e scevro da potenziali conflitti. In questo passaggio si può riscontrare la forte assonanza con la visione di Amartya Sen. “L’irrinunciabilità identitaria”, scrive Remotti, si esplica come il “bisogno fondamentale, determinante, ossessivo” e deve essere oltrepassato perché implica una pericolosa selettività e riduzione, “in quanto con essa, si coglierebbero dei fenomeni e se ne perderebbero molti altri, altrettanto interessanti e decisivi”.
Queste considerazioni esortano ad andare oltre, forse, proprio perché “l’identità” in fondo “non esiste”, ma esisterebbero solo modi diversi di organizzare il concetto che viene sempre in qualche modo, costruito, inventato[30].
L’altro elemento che emerge nell’argomentare sull’identità è la separatezza. “La faccenda in sé è da intelletto tabellesco”[31]: l’irrinunciabilità sembra esprimere la necessità di incasellare e la separatezza di tagliare, recidere per riconoscersi. Nella delineazione di sé stessi rispetto ad un’alterità, sembrerebbe, infatti, essere presente anche un’azione immanente di separazione e di esclusione. Con la separatezza, seguendo le considerazioni di Remotti, offriamo all’idea di identità una stabilità; essa è “maggiormente a suo agio, quando si separa” perché assume “più nitidezza e visibilità ed appare più facilmente garantita”. Se viene centralizzato e reso esclusivo quest’elemento di separatezza si rischia di avviare una concezione fissa, monolitica ed escludente dell’alterità.
Una modalità che implica la nascita di conflittualità, che “separa noi/ gli altri e, anziché collocare noi in mezzo agli altri, posiziona il noi a parte”[32].
È necessario riconoscere che la separatezza simboleggia una leva imprescindibile nella enucleazione di ciò che sostanzia un’individualità, ma non dovrebbe divenire l’elemento preponderante, né essere concepito come un’essenzialità sostanziale fissa. Questa precauzione concettuale dovrebbe essere adottata per tutti i molteplici fattori che determinano le individualità.
Ogni forma concettuale, categoria di pensiero, prassi politica in materia dovrebbe essere scevra di esclusività e rigidità. Ad imporre la mobilità, porosità e provvisorietà[33] è la coesistenza di gruppi etnici differenti, il contatto necessario tra genti provenienti da luoghi diversi, portatrici di diversi universi simbolici. La suddivisione delle persone secondo gli elementi esclusivi della civiltà, cittadinanza, religione o della cultura come categorie rigide, non suscettibili di mutazioni, non può essere considerata adeguata alle temperie multiculturali contemporanee.
Se la riflessione sul processo identitario non subisce questa attualizzazione concettuale essa rischia di rimanere irretita nella sterilità di un approccio obsoleto, come quello multiculturale che sembra promuovere una società ideale, non fatta di individui in carne e ossa, ma di caselle inanimate da giustapporre.
Lo scopo di questo breve mio articolo era di far emergere una modalità filosofica di elaborare, comprendere, vivere l’identità che non fosse escludente, ma integrativa, dinamica. Una modalità altra, che nasca dall’ineludibile esigenza relazionale e dialogica con gli altri.
Le riflessioni antropologiche e filosofiche prese in considerazione, sono tutte accomunate dallo stesso presupposto: l’identità dell’uomo è l’esclusivo esito delle sue costruzioni. Questa premessa sembra echeggiare la convinzione espressa dall’umanista Pico della Mirandola, nella seconda metà del ‘400: “L’uomo avrebbe in sé tutto quanto Dio ha creato e decide di volta in volta cosa essere”[34].
Conclusione
L’obiettivo di questo articolo è stato quello di rintracciare una nuova modalità di intendere ed esprimere l’identità nello scenario culturale contemporaneo.
Obiettivo raggiungibile innanzitutto attraverso il superamento di una concezione dell’io espressa nei termini esclusivi di un elemento portatore di specificità-singolarità, che ha mostrato di fungere da possibile punto di riferimento per la superiorità ed il dominio di una cultura sull’altra.
Si è mostrato la necessità di travalicare tale concezione perché essa è promotrice di una visione limitante e diminutiva delle differenze. A questa concezione definitiva, chiusa, che fissa un confine quasi invalicabile tra il Sé e l’Altro, si è contrapposta una modalità interculturale di pensiero che può costituirsi come criterio-guida per riconoscere ed esprimere la complessità delle identità individuali e collettive.
Un pensiero aperto alla decostruzione dei punti di vista valoriali e culturali di ciascuno, antidogmatico, rispettoso delle differenze e volto alla comunicazione ed alla relazione reciprocamente arricchente.
L’interculturalità come possibilità di costruire relazioni feconde tra le differenze si profila come un nuovo modo di guardare il mondo e di viverne la complessità culturale in cui versa oggi e che in fondo è la stessa complessità che caratterizza la natura umana qualificandola come plurale.
Essa, come è stato messo in luce in questo articolo, si contrappone alla visione puramente descrittiva del multiculturalismo che, al di là dei facili entusiasmi iniziali e delle intenzionalità dei suoi promotori, acuisce l’incomunicabilità, le assolutizzazioni e i fondamentalismi. In particolare, attraverso una ricognizione di alcune visioni filosofiche, antropologiche, etiche, pedagogiche e sociologiche[35] si è giunti a rintracciare nella Filosofia interculturale un orizzonte teorico-pratico per l’ascolto, l’accoglimento, la comprensione e la condivisione delle identità altre.
Essa rappresenta quel modo di esprimere ed affrontare la complessità dell’identità e di modulare la relazione io-altro che ci eravamo proposti di rintracciare.
Quest’orizzonte concettuale esprime tutte le proposte di pensiero che hanno caratterizzato gli itinerari analitici da noi scelti perché favorenti il pensare interculturale. Riteniamo opportuno fare un brevissimo excursus richiamando alla memoria tali concezioni al fine di palesare con nitidezza la pertinenza della Filosofia interculturale come quel pensare altrimenti che si è ricercato.
Attraverso la filosofia di Paul Ricoeur abbiamo messo in luce il concetto di identità che ha in sé, come sua dialettizzazione, l’altro. L’implicazione dell’alterità nel cuore stesso del soggetto ha inferto una prima scossa alla decostruzione di quella maniera monolitica di ragionare sopra citata. La concezione del Sé profondamente implicato con l’Altro ha rappresentato la possibilità di affrancarsi da quel linguaggio che si è avvalso principalmente di categorie concettuali oppositive (proprio-estraneo; bene-male, io-altro) per argomentare intorno all’intersoggettività.
Con la visione del filosofo francese abbiamo segnalato la connotazione profondamente etica della relazione con l’Altro: l’identità è intessuta di alterità e presenta perciò una naturale propensione all’ accoglimento che non va annichilita, ma lasciata essere. Quest’attenzione all’Altro nella sua specificità storicamente determinata è uno dei tratti salienti della Filosofia interculturale.
Essa, infatti, mira a combattere ogni livellamento delle differenze attribuendo valore ad ogni visione culturale. Il suo proposito di conoscenza e contaminazione reciproca muove infatti dal presupposto dell’eguale dignità e plausibilità di diverse visioni del mondo[36].
Gli studi dei pensatori Amartya Sen, Clifford Geertz e Seyla Benhabib sono stati utili per mettere in rilievo la preziosità di una declinazione plurale della cultura e dell’identità dell’uomo.
Le culture hanno come nota costitutiva la processualità perché esse sono frutto di un lavorio di costruzioni e ricostruzioni simboliche.
Nelle luci, nelle ombre e nelle discontinuità di cui sono portatrici risiede la formazione delle identità. Quest’ultima non sarebbe da scoprire, come sostiene ad esempio la linea di pensiero comunitaria, ma sarebbe il frutto di un atto deliberativo razionale. Una conseguenza delle scelte e dell’esercizio della libertà.
Scegliere razionalmente significa dare delle preferenze, attribuire delle priorità facendo un buon/libero uso della ragione e affrancarsi dal conformismo, dogmatismo e dai valori assoluti o monolitici. Sulla stessa linea d’intenti si muovono le argomentazioni relativistiche che sottolineano a più riprese la storicità e la dinamicità delle culture. Il relativismo guarda ad esse come a cantieri sempre in costruzione in cui gli individui forgiano ed acquisiscono le loro affiliazioni.
Questa metafora viene rinvenuta nel testo dello studioso Marco Aime Gli specchi di Gulliver ed è efficace per far emergere il valore aggiunto della visione relativista rispetto alle retoriche del multiculturalismo. Il relativismo può considerarsi la premessa concettuale per la delineazione di un approccio efficacemente plurale alle tematiche identitarie perché si configura come “l’intenzione di leggere le pagine che compongono l’intero libro della vita, senza avere la pretesa di far valere quelle scritte da sé”[37].
Molteplici altri spunti hanno consentito di procedere oltre il multiculturalismo: il concetto di cittadinanza del mondo elaborato dalla studiosa statunitense Martha Nussbaum, la visione bidimensionale della giustizia di Nancy Fraser e la teoria delle capacità condivisa con Amartya Sen[38].
Un’ultima prospettiva che si può ancora annoverare tra le teorie e gli strumenti pratici che favoriscono l’interculturalità è la consulenza filosofica. Una disamina del significato della filosofia interculturale renderà definitivamente chiara la tesi su esposta. A tal fine ripercorreremo le considerazioni del filosofo Raul Fornet Betancourt che in Trasformazione interculturale della filosofia traccia un interessante percorso analitico sul tema. Un’importante osservazione preliminare dà avvio alle argomentazioni del filosofo cubano: è necessario tenere presente che stiamo circumnavigando un territorio nuovo[39] che implica pertanto un certo spirito pioneristico nella trattazione. Bisogna tenere in considerazione che non ci sono ancora basi teoriche a sufficienza e che la materia in questione è soggetta a versioni metodologiche ed ermeneutiche disparate. Seguendo la visione di Betancourt molteplici sono gli elementi che gli conferiscono l’attribuzione di novum nel panorama del pensiero filosofico. Innanzitutto, il suo porsi come processo aperto alle differenze, la volontà di travalicare la tendenza ad assolutizzare le visioni, l’intenzionalità di evitare ogni possibile predominio da parte di una concezione sull’altra. Tutte note che intendono delineare un filosofare critico che si arricchisce delle e dentro le differenze. Siamo dinanzi ad un nuovo modo di intendere “il proprio e l’altrui”. La criticità auspicata viene espressa con una metafora: l’essere dell’io, che si manifesta nell’appartenenza ad una certa cultura, tradizione, preferenze, valori morali, deve essere vissuto non come un insieme di valori assoluti, ma come un ponte finalizzato al passaggio verso l’alterità.
La filosofia interculturale si pone come paradigma teorico per comprendere l’epoca presente.
Essa per essere attuale deve “compromettersi storicamente con il compito di fare in modo che il nostro tempo sia un nostro che possa essere pronunciato da tutta l’umanità come manifestazione di una coappartenenza solidale”[40].
Si delinea così una pratica umana che deve incarnarsi nella gente: “l’interculturalità vuole essere innanzitutto il modo in cui la gente pratica l’umanità e diventa pratica in umanizzazione cioè cresce in umanità”[41].
Con l’aggettivo attuale non si intende la trattazione dei temi in voga nella contemporaneità, ma il risultato di “un abitare criticamente il mondo” considerando ciò che è urgente di fronte alla sopravvivenza dell’umanità. La scelta metodologica principale, infatti, è quella di focalizzare l’attenzione su ciò che accade nel nostro tempo con gli occhi delle vittime emarginate perché non conformi al disegno di un’umanità globalizzata. Da queste considerazioni emerge con chiarezza la disposizione etica della filosofia dell’interculturalità[42] che impone il situarsi nella diversità culturale con particolare attenzione rivolta alle situazioni di emarginazione, distruzioni ed umiliazioni operate in particolare dalle imprese coloniali. L’intenzionalità è quella di rendere manifeste le molteplici voci culturali, affrancando il pensiero dall’asse interpretativo occidentale.
La razionalità occidentale, che sembra volersi cullare sull’identità monoculturale, statica e monolitica, è intenzionata ad individuare una nota comune nella diversità delle visioni provocando un appiattimento limitante delle prospettive[43].
Nella contemporaneità globalizzata ciò che è in gioco è la diversità culturale. Essa rischia di essere annichilita dalla standardizzazione dei modi di vita operata dalla cultura occidentale imperante[44]. Nella stessa linea di considerazioni muove l’analisi di Giuseppe Cacciatore che, a più riprese e in più luoghi del suo itinerario filosofico, ribadisce l’uguale dignità di trattazione filosofica alla totalità delle culture del mondo nelle loro particolarità[45]. Il filosofare del nostro tempo si configurerebbe come reazione al disegno neoliberale del mondo. Esso si porrebbe dinanzi alle sfide scaturenti dalla globalizzazione per travalicare l’immagine monolitica, unidimensionale della realtà.
Questo passaggio verso una visione plurale sarebbe reso possibile da un nuovo processo di apprendimento antropologico.
Betancourt tratteggia la contemporaneità come quella dimensione che vive un’omologazione della vita e dell’essere umano. In essa vigerebbe una visione antropologica incentrata intorno ai termini di funzionamento, possesso e dominio in cui si è smarrito ogni senso di contingenza e contestualità. La proposta interculturale è quella di essere un’alternativa di pensiero che compia un ripensamento dell’uomo e della vita e ne inverta il senso di deviazione provocato dalla visone monolitica capitalistica. La filosofia interculturale si pone, nella visione del nostro autore, come il risultato di un’evoluzione inevitabile del pensiero, che da monoculturale richiede una razionalità dialogica sinfonica. Da questa considerazione si inizia a rendere più chiaro il senso della Trasformazione[46] della filosofia che va intesa come una necessaria revisione, indotta dal nostro tempo, sull’intero impianto delle categorie concettuali che la connotano: prime fra tutte l’universale[47].
La filosofia deve rivedere la sua normatività e mettere in discussione la sua chiusura ad un solo ambito culturale.
Il concetto di universale, come ha osservato il filosofo Jullien, ha funto nella storia del pensiero da nozione centrale per modulare il rapporto tra le culture. Alla luce dei tempi contemporanei, caratterizzati dalla globalizzazione e dagli ineludibili conflitti culturali, esso va sottoposto a critica. Deve essere compiuta una ricognizione della sua genealogia che conduce alla messa in evidenza della non pertinenza della nozione e della sua inefficacia. Queste criticità sorgono dall’uso non trasparente e non neutrale che se ne è fatto. Il filosofo francese ci invita a ripensare il concetto oltre i limiti del contesto europeo, chiederci quale sia la sua pertinenza. Esso deve essere inteso come un’idea regolatrice che orienta la condivisione e la solidarietà tra le culture in virtù di un senso dell’umano che lo sostanzia[48].
Raul Fornet Betancourt elabora un concetto di universale, in forte armonia con le considerazioni di Jullien, slegato dall’unità e inteso come elemento propulsivo della solidarietà nei confronti della molteplicità di “universi” che costellano il mondo.
Il fine essenziale della filosofia interculturale è infatti la condivisione delle differenze e la solidarizzazione tra esse. Il mondo deve essere guardato a partire dalla pluralità prendendo sul serio ciascuna visione individuale e riconoscendola nel suo diritto di essere sé stessa.
In linea con queste considerazioni viene definito il concetto di cultura come insieme di valori nel quale un soggetto nasce, cultura propria, e del quale ogni giorno sceglie di appropriarsi.
Come situazione che lo caratterizza alla nascita e lo contraddistingue come processo di scelta.
Non si tratterebbe di un’originarietà immodificabile, ma mutevole, un prodotto di un processo di discernimento[49]. La categoria centrale della nuova filosofia è dunque la storicità delle culture, del mondo, della vita. La storicità che, a dirla con un’espressione centrale nella visione di Jullien, costituisce lo scartotra l’Io e l’Altro.
Il fine del filosofare interculturale è realizzabile attraverso un dialogo tra le culture: capace di creare processi interculturali. Betancourt si sofferma ampiamente sulle caratteristiche e gli scopi delle relazioni interculturali. Queste implicano una serie di difficoltà tutte legate alle questioni ermeneutiche e metodologiche nelle quali ci si imbatte. Altre difficoltà nascono dalla necessità di compiere una mutazione di pensiero radicale per avviare un’interazione feconda. Il fine del dialogo è la creazione di una convivenza relazionale tra le diversità. Esso ha, in quanto strumento della filosofia interculturale, una caratteristica profondamente etica perché è guidato dal valore dell’accoglienza, condivisione e della solidarizzazione:
Il dialogo interculturale implica perciò una speciale qualità etica che lo caratterizza come forma di vita o di atteggiamento fondamentale teorico pratico il cui esercizio, andando oltre la tolleranza ed il rispetto, fonda l’accoglienza dell’altro come soggetto che, per intervenire e partecipare non deve pagare per primo i diritti di dogana né chiedere un permesso di lavoro. Il dialogo interculturale ha a questo livello il carattere di un progetto etico guidato dal valore dell’accoglienza dell’altro in quanto realtà con cui si vuole condividere la sovranità e con il quale quindi si può condividere un futuro che non è determinato unicamente dal mio modo di comprendere e di desiderare la vita[50].
Il dialogo tra le culture, così declinato, sembra rappresentare anche per Francois Jullien l’alternativa all’uniformazione diffusa. È interessante richiamare alla memoria una digressione di quest’autore sul concetto di dialogo erroneamente inteso e sulla proposta del concetto sopra accennato di “scarto” come termine chiave di un’interazione realmente feconda tra le differenze.
Si è soliti utilizzare la nozione di dialogo per riflettere sulle modalità d’interazione tra le culture, ma secondo il filosofo francese questa nozione non rende con efficacia la pluralità che lo dovrebbe connotare. Esso vien definito soventemente per opposizione concettuale allo scontro delle civiltà[51]. Solo lo “scarto” può avviare una comunicazione feconda. È necessario porsi nello “scarto”, come dimensione critica nella quale rivedere la propria cultura e quella dell’altro.
Il termine dialogo mostra una debolezza concettuale ed un’inefficacia pratica perché “nasconde dietro la bandiera delle buone intenzioni una dispersione troppo sbrigativa dell’idea del Tutto”. Affinché il dialogo possa costituire una reale alternativa all’uniformazione deve rendere manifesta la distanza, lo scarto tra le culture. Deve condurre ad un lavoro reciproco di autoriflessione e confronto non cercando di elaborare una situazione intermedia, ma inducendo a considerare vana la contraddizione esistente. In gioco c’è la proposta di una modalità di vivere la differenza fatta di dia-logicità dialettica, che non annulla, ma lascia essere le posizioni antitetiche.
Lo scarto, dunque, è una prospettiva di pensiero aperto, non dogmatico fluido che consente l’esplorazione di nuove possibilità[52].
Riteniamo opportuno soffermarci ancora una volta sulla concezione dell’universale proposta dalla filosofia interculturale per mostrare come essa risponda in pieno a quel pensare altrimenti che ci eravamo proposti di ricercare. Il senso del linguaggio comune ci induce ad affiancare intuitivamente il termine interculturalità ad una ricerca di universalità.
Questa connessione può essere considerata valida solo se l’universalità non è il frutto esclusivo di una concettualizzazione astratta e formale. Perché, secondo Betancourt, la vera universalità è la contestualità storica della vita umana in tutta la sua pluralità. La caratterizzazione di contestualità riconosciuta alla filosofia interculturale non chiude la strada all’universalità, ma ci segnala che quest’ultima è raggiungibile attraverso processi di interscambio e di comune comprensione. L’intento è quello di favorire un’universalità delle contestualità attraverso una contestualizzazione delle universalità condivise. L’intenzionalità è teorico-pratica: attraversare la molteplicità e complessità delle identità, concependo la diversità come occasione che arricchisce ed impreziosisce la modalità del vivere e del comprendere contemporaneo.
Bibliografia
Aime, M., Gli specchi di Gulliver, in difesa del relativismo, Torino, 2009.
Bauman, Z., Vita liquida, Roma-Bari, 2006.
Belardinelli, S., L’ordine di Babele. Le culture tra pluralismo e identità, Soveria Mannelli, 2018.
Bettini, M., Hai sbagliato foresta. Il furore dell’identità, Bologna, 2020.
Boncinelli, E., Le forme della vita. L’evoluzione e l’origine dell’uomo, Torino 2000.
Cacciatore, G., D’Anna, G., Interculturalità tra etica e politica, Roma, 2010.
Cacciatore G, Colonnello P. Santasilia S., Ermeneutica tra Europa e America Latina, Roma, 2008.
Cacciatore G., Identità e filosofia dell’interculturalità, in «Iride», 2, 2005.
Cacciatore, G., Identità, pluralismo, universalismo dei diritti, in A De Simone (a cura di), Identità, spazio e vita quotidiana, Quattro venti Urbino, 2005.
Cambi, F., Incontro e dialogo, prospettive della pedagogia interculturale, Roma, 2008.
Cartesio, R., Meditazioni metafisiche, in Opere in, a cura di E. Garin, Bari, 1967, vol.1.
de Benoist, A., La scomparsa dell’identità. Come orientarsi in un mondo senza valori, Cesena, 2023.
Della Mirandola, G. P., Discorso sulla dignità dell’uomo, a cura di Giuseppe Tognon Brescia, 1987.
De Waal, F., Naturalmente buoni, il bene ed il male nell’uomo e in altri animali, Milano, 1997.
Fistetti, F., Multiculturalismo, una mappa tra filosofia e scienze sociali, Novara, 2008.
Fornet Betancourt, R., Trasformazione interculturale della filosofia, Bologna, 2006.
Foucault M., Il pensiero del fuori, Milano, 1966.
Geertz, C., Interpretazione delle culture, Bologna, 1987.
Gehlen, A., L’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, 2010.
Giddens, A., Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna, 1994.
Habermas, J., Il futuro della natura umana, i rischi di una genetica liberale, Tornino, 2000.
Hall, S., La questione multi-culturale in Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi coloniali e post coloniali, Roma, 2000.
Huntington, S. P., Lo scontro delle civiltà ed il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, Milano, 2000.
Jonas, H., Il principio responsabilità, un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 2003.
Jonas, H., L’ingegneria biologica, una previsione, in Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Saggi filosofici, Bologna, 1991.
Jullien, F., L’universale ed il comune, il dialogo tra le culture, Bari, 2010.
Kurotschka, Gessa V., Cacciatore, G., Saperi umani e consulenza filosofica, Roma, 2005.
Lanzillo, M. L., Il Multiculturalismo, Bari, 2005.
Mazzarella, E., Vie d’uscita, l’identità come programma stazionario metafisico, Genova, 2004.
Pannikar, R., Pace e interculturalità, una riflessione filosofica, Milano, 2002.
Remotti, F., Contro l’identità, Bari, 2008.
Said, Ed., Orientalismo, L’immagine europea dell’Occidente, Milano, 2001.
Sciuto, C., Non c’è fede che tenga. Manifesto laico contro il multiculturalismo, Milano, 2018.
Sen A., Identità e violenza, Roma-Bari, 2006.
Sen, A., Fassino, P., Maffettone, S., Giustizia globale, Milano, 2006.
Sen, A., Reason before identity (1999); trad. it., La ragione prima dell’identità, in La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità,Bologna, 2000.
Searle, J.R., La mente, Milano, 2005.
Tarizzo, D., Il pensiero libero, la filosofia francese dopo lo strutturalismo, Milano, 2003.
Viola F., Democrazia culturale e democrazia delle culture, in Studi emigrazioni, migration studies, XXXVIII, p.144,200, in www.unipa.it.
[1]J. Habermas, Il futuro della natura umana, I rischi di una genetica liberale, Torino, 2002, pp. 23, 24.
[2]Ivi, p. 23.
[3]H. Jonas, L’ingegneria biologica, una previsione, in Id., Dalla Fede antica all’uomo tecnologico, Saggi filosofici, traduzione italiana di I. Bettini, Bologna, 1991. p. 243. Cfr. Il principio responsabilità, Un’etica per la civiltà tecnologica, Torino, 2002. In quest’opera, Jonas affronta, in maniera diffusa, la pericolosità etica suscitata dagli sviluppi della genetica. Anche qui, il filosofo tedesco, individua come rischio più preoccupante l’eventualità di un pieno controllo dell’uomo sull’evoluzione per fini eugenetici. Questa eventualità viene dall’autore considerata come la realizzazione di un obiettivo che appartiene all’uomo: “[…] il sogno ambizioso dell’homo sapiens può essere espresso nella tesi, secondo cui l’uomo vorrebbe prendere in mano la propria evoluzione biologica, non soltanto con lo scopo di preservare la specie nella sua integrità, anche per migliorarla e trasformarla in base ad un proprio progetto. Se ne abbia il diritto, se sia qualificato ad assumere tale ruolo creativo, ecco la questione più seria che possa venire posta all’uomo che si trova improvvisamente a disporre di un simile potere fatale”. Ivi, pp. 26-28.
[4]Una contemporaneità tecnologica che sembrerebbe proporre, per alcuni versi, la piena realizzazione della strumentalizzazione degli esseri umani, individuata da Jonas. “[…] l’uomo stesso è diventato uno degli oggetti della tecnica, l’uomo faber rivolge a sé stesso la propria arte e si appresta a riprogettare con ingegnosità l’inventore e l’artefice di tutto il resto”, così Jonas esprime la riduzione dell’uomo ad oggetto della tecnica. Ivi, p. 23.
[5]Cfr., J. Habermas, J., Il futuro della natura umana, I rischi di una genetica liberale, cit. pp. 54-56, 67-70. Secondo Habermas, l’identità umana come identità biologica coincide con ciò che ci siamo dati già con il solo utilizzo della pratica del pre-impianto.
[6]E. Boncinelli, Le forme della vita. L’evoluzione e l’origine dell’uomo, Torino, 2000. Questo interrogativo accomuna scienziati e filosofi, coinvolgendo i diversi ambiti del sapere. Il genetista Boncinelli scrive: “Che cos’è che fa dell’uomo l’uomo: le sue capacità mentali? La stazione eretta? L’utilizzazione degli strumenti? Probabilmente un po’tutte queste cose anche se non è molto chiaro quale sia venuta prima e quale dopo”. Ivi, p. 148.
[7]Si segnala sull’argomento F. De Wall, Naturalmente buoni, Il bene ed il male nell’uomo e in altri animali, Milano, 1997. L’autore, un primatologo, attraverso lo studio delle scimmie antropomorfe, mostra che è possibile rinvenire nei nostri antenati non umani atti di violenza e prevaricazione, ma anche forme di solidarietà e tolleranza.
[8] Il pensatore statunitense J. R. Searle ha individuato nell’intelligenza, nella effettiva capacità di comprendere la cifra distintiva dell’uomo rispetto al computer: l’uomo comprende, il computer esegue. Secondo l’autore de La mente, il progetto dell’intelligenza artificiale forte fallisce perché non crea con il computer il corrispettivo elettronico dell’intelligenza umana; esso ha successo pieno solo nel simulare la cognizione umana. Searle ha mostrato la grande differenza che intercorre tra la computazione e la comprensione reale in un esperimento mentale. “[…] se l’intelligenza artificiale forte fosse vera – argomenta Searle in La Mente – allora chiunque dovrebbe essere in grado di acquisire una capacità cognitiva qualsiasi semplicemente implementando il programma di computer che simula tale capacità. Mettiamo l’idea alla prova con la lingua cinese. Io non capisco una parola di cinese, nemmeno distinguere la scrittura cinese da quella giapponese. Ma immaginiamo che io sia chiuso in una stanza con alcune scatole piene di simboli cinesi, che abbia un manuale di regole, programma informatico che mi consenta di rispondere a domande formulate in cinese. Ricevo simboli che a mia insaputa sono domande, guardo nel manuale cosa ci si aspetta che io faccia; prendo dei simboli dalle scatole, manipolo secondo le regole del programma e mando fuori i simboli richiesti, che sono interpretati come risposta. Possiamo supporre che io superi il test di Turing per la comprensione del cinese ma non capisco una parola di cinese e se, pur implementando il programma informatico appropriato, io non capisco il cinese, allora nessun altro computer lo capisce per il solo fatto di implementare il programma, perché nessun computer possiede qualcosa che io non abbia. Potevi rendere conto della differenza tra computazione e comprensione reale se immaginate come vivrei invece la situazione dovendo rispondere a domande in inglese. Immaginiamo che nella stessa stanza mi siano rivolte anche domande in inglese, cui io rispondo. All’esterno, le risposte alle domande in inglese ed a quelle in cinese appaiono ugualmente buone, ma vista dall’interno la differenza è enorme. Quale è esattamente? In inglese, capisco ciò che le parole significano, in cinese non capisco niente. Per il cinese sono un computer”. J.R., Searle, La mente, Milano, 2005. pp-81-82.
[9]Come Cartesio ci ha suggerito nelle Meditazioni Metafisiche, Cogito ergo sum, penso dunque sono, esisto. Il cogitare qualificherebbe in maniera esclusiva, il soggetto umano che esiste, è in virtù della capacità di pensare. L’identità dell’uomo è nel suo essere razionale. Meditazioni Metafisiche, in Opere, vol. 2, p. 205, 206.
[10]Diverse sono le correnti di pensiero che mirano alla definizione dell’identità dell’uomo a partire dalla differenziazione dal suo possibile clone elettronico. L’elemento di differenziazione risiederebbe nel possesso dell’empatia come caratteristica esclusivamente umana. Eugenio Mazzarella, in Identità umana ed artificio, idee per una libertà sostenibile, si interroga, sulla scia di alcune osservazioni di Philip K. Dick, intorno a cosa è umano, cosa è reale, cosa non lo è ed individua come caratteristica peculiare dell’uomo la capacità di sentire l’altro, il bisogno dell’altro per la vita di ciascuno, l’empatia non riproducibile nel robot. Le osservazioni di Dick, secondo Mazzarella “[…] bisogna tenerle a mente, quando la filosofia riflette sulle possibilità di ibridazione tecnologica che tecnica e biotecnologia offrono oggi alla struttura psico-biologica e in definitiva storica dell’esserci umano, alla sua identità diveniente, al modo in cui abita il suo mondo e sé stesso. Giacché ciò che è in gioco è proprio l’identità a sé stessa riconoscibile di ciò che fino ad oggi è stato umano”. Nella contemporaneità tecnicizzata, in cui viviamo, viene meno, secondo l’autore, l’empatia, la capacità di sentire l’altro, perché “viene meno l’avvertimento comunitario della nostra vita” cioè la consapevolezza che la nostra vita si difende e nasce con la vita di qualcun altro. Ciò che rende umano l’uomo, l’empatia, caratteristica non riproducibile nemmeno in via di simulazione nel robot, “crolla con il tentativo di raggiungere una durata infinita dell’individualità, pensiamo al tentativo delle biotecnologie di disattivare il programma di invecchiamento dell’organismo” V. Gessa Kuroschka, G. Cacciatore, Saperi Umani e consulenza filosofica, Roma, 2005, in particolare pp.107-117.
[11]M. L. Lanzillo, Il Multiculturalismo, Roma-Bari, 2005. pp. 20, 21.
[12]Cfr., G. Cacciatore, G. D’Anna, Interculturalità, Tra etica e politica, Roma, 2010. L’approccio multiculturale, come mettono in luce gli studiosi Cacciatore e D’Anna, porterebbe ad elaborare “concezioni oggettivanti e descrittive delle differenti culture, mentre l’interculturalità intende formulare relazioni progettuali tra le differenze”. È interessante notare che i due studiosi sottolineano e, nel contempo, superano l’usuale polarizzazione tra multiculturalismo e intercultura: “il multiculturalismo si costituisce come il campo di descrizione e di rilevazione delle differenze culturali, mentre l’atteggiamento interculturale si determina come terreno di possibilità di costruzione del dialogo tra le culture”, “essi divengono tasselli complementari all’interno di una più generale teoria critica dell’intercultura”. Il fine della critica all’interno di una possibile metodologia dell’intercultura è “rintracciare le condizioni di possibilità all’interno delle quali poter organizzare un pensiero dell’intercultura che sappia discernere, penetrare ermeneuticamente e analizzare il tema della differenza in tutta la sua portata dialettica, conflittuale e problematica”. Ivi, pp. 11-12.
[13]Cfr V. Gessa-Kurotschka, G. Cacciatore, Saperi umani e consulenza filosofica, Roma, 2007, in particolare il saggio di L. Cortella, Identità e riconoscimento, pp. 193-197. L’autore mostra tale necessaria fluidità sostenendo che: “Il modo usuale di pensare l’identità [..] che colloca l’identità dal lato della specificità, come ciò che caratterizza il momento individuale[..]” sia obsoleto e sostiene che “l’identità dell’individuo sia il prodotto sociale, il prodotto di interazioni soggettive”.
[14]Cfr. D. Tarizzo, Il pensiero libero, la filosofia francese dopo lo strutturalismo, Milano, 2003, pp. 9-23.
[15]M. Foucault, Il pensiero del fuori, Milano, 1966, p. 116.
[16]Mettendo in discussione la tesi di Cartesio, questi filosofi francesi hanno posto le basi per nuovi interrogativi, a dirla con le parole della studiosa Francesca Brezzi: “non più ti estin (cosa è), ossessione della metafisica classica, ma ti esti (chi è?), chi sono io? Chi sei tu?”. Cfr. in proposito V. Gessa-Kurotschka, G. Cacciatore, Saperi umani e consulenza filosofica, op. cit. in particolare il saggio F. Brezzi, Oltre la differenza verso il riconoscimento, p. 201.
[17]L’influenza delle moderne tecnologie della comunicazione sulla struttura della società in cui viviamo e sulla modalità d’istaurare le relazioni è al centro di diversi studi sociologici.
Si veda in proposito A. Giddens, Le conseguenze della modernità: fiducia e rischio, sicurezza e pericolo, Bologna, 1994. Bologna, 1994; Z. Bauman, Vita Liquida, Roma-Bari, 2006.
[18]Nelle riflessioni svolte in questo paragrafo sono stati elaborati alcuni suggerimenti rilevati durante il seminario Identità plurime e relazione interculturale, tenuto dal Dott. Rosario Diana, presso l’Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1,4,9,10, giugno/2010.
[19]Cfr. in proposito F. Remotti, Contro L’identità, Roma, 1996, pp. 16-19. A. Gehlen, l’uomo, la sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, 1983. Il noto filosofo e antropologo tedesco si sofferma più volte sull’incompiutezza biologica della natura umana, giungendo a definire l’uomo come un essere carente: “Dal punto di vista morfologico – a differenza di tutti i mammiferi superiori – l’uomo è determinato in linea fondamentale da una serie di carenze, le quali di volta in volta vanno definite nel senso biologico di in adattamenti, non specializzazioni, primitivismi, cioè di carenze di sviluppo: e dunque in senso essenzialmente negativo”. L’autore propone un’immagine dell’uomo diametralmente opposta a quella proposta dall’evoluzionismo darwiniano: l’uomo non sarebbe il risultato perfetto del processo evolutivo, ma sarebbe “l’animale ancora non definito”. Quest’ultima espressione appartiene a Nietzsche. Secondo Gehlen è un’espressione esatta ed ha un duplice senso: “In primo luogo vuol dire che non sussiste ancora un accertamento di ciò che l’uomo propriamente è. E in secondo luogo l’essere umano è per qualche verso incompiuto, non costituito una volta per tutte”. L’immagine dell’uomo che emerge è quella di un uomo carente perché privo di “specializzazioni specifiche”, ma capace attraverso l’azione di costruire sé stesso. Il tratto distintivo dell’umano risiede nell’Weltoffenheit, nell’apertura al mondo attraverso la quale non si colloca solo in “un ambiente”, ma ha mondo, vivendo e adattandosi attraverso le azioni. In tale prospettiva l’identità culturale è il risultato delle costruzioni degli individui e diviene una sorta di “seconda natura”. Ivi, pp.60-63; 36.
[20]C. Geertz, Interpretazione delle culture, Bologna, 1987, p. 92.
[21]Ivi, pp. 4-5.
[22]Si veda in proposito S. Hall, La questione multi-culturale in Il soggetto e la differenza. Per un’archeologia degli studi coloniali e postcoloniali, Roma, 2000. Qui si discorre dell’irrinunciabilità dell’identità come centralità, che nella contemporaneità, avrebbe assunto la delineazione dell’io e come impossibilità dei soggetti di sfuggire al loro posizionamento. Secondo l’autore la politica che non vede questa necessità di posizionamento delle identità non è confacente ai tempi nuovi.
[23]M. Aime, Gli specchi di Gulliver, in difesa del relativismo, Torino, 2009, p. 74.
[24]Reason Before Identity è la trascrizione di una lezione pubblica tenuta da Amartya Sen nel 1998 presso l’università di Oxford ed ha come tema il ruolo della ragione nella scelta dell’identità. A. Sen, Reason before identity (1999); trad. it, La ragione prima dell’identità, in La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità, Bologna, 2000, pp. 3-29.
[25]Ivi, p.10; Id., Identità e violenza, Roma-Bari, 2006, p. VII.
[26]A. Sen, P. Fassino, S. Maffettone, Giustizia Globale, Milano, 2006. pp. 27, 28.
[27]A. Sen, Identità e violenza, op. cit., p. IX.
[28]A. Sen, Identità e violenza, op.cit., p.113.
[29]F. Remotti, Contro l’identità, Bari, 2008. pp. 60, 61.
[30]Ivi, pp.5,6.
[31]Ivi. pp.8,9.
[32]Ivi. pp. 32-37, 44-46.
[33]Cfr, F. Fistetti, Multiculturalismo una mappa tra filosofia e scienze sociali, Novara, 2008. Nella visione dello studioso contemporaneo, Francesco Fistetti, tale precarietà dei concetti è raggiungibile attraverso un processo di fluidificazione: “bisogna lavorare per smarcare, decentrare e fluidificare i concetti e le pratiche di cui disponiamo e che formano la trama della nostra razionalità”. P.126.
[34]G. Pico della Mirandola, Discorso sulla dignità dell’uomo, a cura di Giuseppe Tognon, Brescia, 1987, pp.3-7.
[35]La ragione del coinvolgimento delle scienze umane nella loro molteplicità ha la sua motivazione nella natura stessa della questione dell’identità. La trattazione di temi quali la formazione dell’individualità, l’intersoggettività, il riconoscimento delle differenze, il conflitto implica un approccio analitico che prevede la lente critica della filosofia, dell’antropologia, dell’etica ed anche delle visioni politiche in quanto è nello spazio pubblico che nascono e si concretano tali argomenti. Uno spazio che alla luce dei tempi contemporanei si definisce con categorie concettuali profondamente mutate basti pensare alla nuova idea di cittadinanza, di confine e di appartenenza. Sul mutamento del senso dell’idea di appartenenza si rimanda alle riflessioni di F. Cambi in Incontro e dialogo, prospettive della pedagogia interculturale, Roma, 2008, pp. 11-21. Sul coinvolgimento dell’etica come intima natura della questione identitaria sul piano interculturale si veda G. Cacciatore, G. D’Anna, Interculturalità tra etica e politica, op.cit., in particolare pp.9-17, 29-65, 101-111.
[36] G. Cacciatore, Identità e filosofia dell’interculturalità, op. cit, p. 241.
[37] M. Aime, Gli specchi di Gulliver, in difesa del relativismo, op. cit, p.72.
[38] L’assonanza di queste proposte analitiche con la Filosofia interculturale che tutte le contiene e le esprime non è una tesi peregrina. Lo studioso Giuseppe D’Anna ha colto una forte convergenza tra le indicazioni contenute nella teoria delle capacità di Martha Nussbaum e la proposta del filosofo Giuseppe Cacciatore di un’etica interculturale. Gran parte della letteratura dedicata alla Filosofia interculturale condivide la messa in discussione dell’universale etico assoluto ed esclusivo. Interculturalità tra etica e politica, op. cit., p.71.
[39] Ivi, p.51, Giuseppe Cacciatore specifica che di filosofia interculturale si è iniziato a parlare tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 specialmente nelle aree filosofiche tedesche e latinoamericane quando si è iniziato ad acuire il problema del multiculturalismo e le questioni annesse che oggi sono imperanti. Cfr. in proposito G. Cacciatore, P. Colonnello, S. Santasilia, Ermeneutica tra Europa e America latina, op. cit, p.50. Id., Identità e filosofia dell’interculturalità, op. cit. p. 236.
[40]R. Fornet Betancourt, Trasformazione interculturale della filosofia, op.cit. p.36.
[41]Ivi, p.43-44.
[42]Sull’etica dell’interculturalità si veda G. Cacciatore, G. D’Anna, Interculturalità tra etica e politica, op., cit. V. Gessa Kurotshka, G. Cacciatore, Saperi Umani e Consulenzafilosofica in particolare il saggio di G.M. Cazzinga, Interculturalità e consenso etico, pp.329-336.
[43]Giacomo Coccolini, nel presentare l’opera del filosofo cubano, individua nel superamento della lettura occidentale monoculturale un significativo passaggio del percorso dell’autore verso il modello di filosofia interculturale. Coccolini specifica che Betancourt non abdica alla razionalità tout court, ma aspira a far emergere le diverse visioni razionali per liberare la filosofia da un’interpretazione unilaterale. R. Fornet, Betancourt, La trasformazione interculturale della filosofia, op. cit. p. 15.
[44]Cfr. in proposito F. Jullien, L’universale ed il comune, il dialogo tra le culture, Bari, 2010. p. VII.
[45]Segnaliamo in proposito alcuni di quei luoghi: G. Cacciatore, G. D’Anna, Interculturalità tra etica e politica, op., cit; V. Gessa Kurotshka, G. Cacciatore, Saperi Umani e Consulenza filosofica ,op. cit.; G. Cacciatore, Identità pluralismo, universalismo dei diritti, in A De Simone (a cura di), Identità, spazio e vita quotidiana, Quattro venti Urbino 2005; Id., Capire il racconto degli altri, in Reset, CXVII, Roma, 2007; Id., Identità e filosofia dell’interculturalità, op. cit; G. Cacciatore, P. Colonnello, S. Santasilia, Ermeneutica tra Europa e America latina, op. cit.
[46]Sulla trasformazione che la filosofia è chiamata a compiere anche Cacciatore si esprime nella stessa direzione d’intenti. Egli congiunge al tema la trasformazione anche l’ermeneutica come lente critica che può coadiuvare la filosofia dell’interculturalità. L’ermeneutica, grazie alle interpretazioni di Gadamer, Ricoeur, Dilthey, non è più soltanto una metodologia dell’interpretazione, ma diviene il metodo attraverso cui ogni aspetto della realtà presente e passata è interpretabile a partire dalla conoscenza del suo carattere storico e culturale. G. Cacciatore, P. Colonnello, S. Santasilia, Ermeneutica tra Europa e America Latina, op.cit., p.7.
[47]Ivi. p.49. Giuseppe Cacciatore ritiene che le categorie concettuali che devono essere riviste per poter recuperare la loro valenza critica rispetto all’ideologia imperante scaturita dalla globalizzazione siano molteplici: «penso alle idee di democrazia, ai concetti di libertà, giustizia, solidarietà, dignità, identità, sviluppo, diritti umani, che sono, proprio perché storicamente determina ti legati ai contesti sociali e culturali continuamente esposti alla crisi ed alla consumazione, ma non per questo diventano ferri vecchi da lasciare nello scantinato ad arrugginire».
[48]Jullien traccia un itinerario critico nei confronti della triade concettuale universale, uniforme, comune finalizzata a mettere in luce come generalmente le nozioni citate siano considerate erroneamente equivalenti o non sottoposte al confronto adeguato. A quest’esplorazione critica il filosofo fa seguire la proposta di un dialogo tra le culture che venga articolato dal piano comune dell’intelligibilità, dall’auto riflessione dell’umano, riflessione su di sé e sull’altro, che valorizzi lo scarto ineludibile tra le culture promuovendo una fecondità della comunicazione. L’intelligenza comune va proposta e non la cultura comune. F. Jullien, L’universale e il comune, il dialogo tra le culture, op.cit., pp. 173-175.
[49]R. Fornet Betancourt, La trasformazione interculturale della filosofia, op.cit., p. 91.
[50]Ivi. p. 98.
[51]Cfr. in proposito S. P. Huntington, Lo scontro delle civiltà ed il nuovo ordine mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, Milano, 2000. La tesi di Samuel Huntington harappresentato dal 1993, anno della pubblicazione dell’articolo Scontro tra le civiltà? che lacontiene, il punto di riferimento principale per una discussione sulle relazioni identità alterità.Relazioni sfocianti, secondo lo studioso americano, nello scontro tra civiltà. Lafonte del conflitto fondamentale del mondo che ci apprestiamo a vivere sarebbe legato allacultura. Lo scontro tra le civiltà del mondo dominerebbe, nella visione di Huntington, lapolitica internazionale in maniera irreversibile. Si veda anche in proposito F. Viola, Democrazia culturale e democrazia delle culture, in Studi emigrazioni, migration studies, XXXVIII, p.144,200, in www.unipa.it.
[52] F. Jullien, L’universale e il comune, il dialogo tra le culture, op. cit., p. 165-171. Per un approfondimento del dialogo tra le culture si veda anche R. Pannikar, Pace e interculturalità, una riflessione filosofica, Milano, 2002; in particolare E., Said, Orientalismo, L’immagine europea dell’Occidente, Milano, 2001. Said riflette sulla modalità di considerare le differenze che possa superare ineluttabilità del conflitto. Come Jullien e Betancourt esprime la necessità di ripensare le categorie del pensiero attualizzarle per poter misurarsi con i tempi contemporanei. Nella sua ottica il primo passo per questo ripensamento è la considerazione della modalità con la quale sono sorte le differenze.
Queste ultime spesso vengono concettualizzate attraverso una proiezione erronee e sbrigativa dell’alterità. L’idea che l’Oriente, il differente per antonomasia, sarebbe stata generata dal contesto occidentale in cui è nata e non da una effettiva conoscenza.