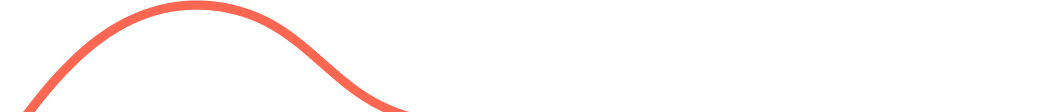L’immagine, di proprietà dell’editore, è qui utilizzata solo ai fini previsti di trattazione del testo e d’incentivare la conoscenza e la diffusione dell’opera.
Recensione di Domenico Bilotti, Università Magna Graecia – Catanzaro.
E-mail: domenico_bilotti@yahoo.it
doi: 10.14672/VDS20242RE3
Titolo: Distruggere Assange. Per farla finita con la libertà d’informazione
Autrice: Sara Chessa
Formato: 14.9 x 2.4 x 21 cm, p. 256
Editore: Castelvecchi, Roma 2023
Ciò che rende un volume di scienza ancor più urgente ed epistemologicamente, oltre che deontologicamente, necessario dei suoi stessi contenuti testuali probabilmente risiede nella necessità di colmare un baco informativo, altrimenti alto come una cortina nebbiosa.
Del giornalista e mediattivista australiano Julian Assange sentiamo parlare sempre di meno, già poco sapendone, e per di più il “filtro” delle notizie rilevanti spesso mette sotto il cono di luce elementi a propria volta confusionari e inadeguati. In tale ottica, il lavoro monografico di Sara Chessa si rivela doppiamente utile: per fare ordine su una vicenda così malamente obliata, persino nei suoi profili più truci, e per rilanciare una vera discussione collettiva sul tema dei diritti nel rapporto tra istituzioni e cittadinanza. Proprio in questo secondo senso, anzi, l’analisi della Chessa si inserisce in un quadro generale nel quale l’istituzione non è più l’istituzione di prossimità del potere statale (la burocrazia amministrativa, il parlamento, il singolo giudice di una corte giurisdizionale), ma quel fascio di poteri diffusi di cui parlava Foucault. Si tratta d’un campo d’azione nel quale le attribuzioni del singolo sono cancellate e annullate in radice, proprio per l’incommensurabile disparità di forze tra libertà individuali e poteri trans-governativi.
La notorietà di Assange s’era sviluppata in un primo tempo secondo tutt’altra direttrice. Attraverso l’organizzazione divulgativa WikiLeaks, già nel 2010, aveva avviato una campagna di diffusione di documenti statunitensi secretati, implicanti e involventi la commissione di crimini di guerra. Non era casuale il nome della realtà associativa per il tramite della quale pubblicava Assange. “Wiki” è diventato il prefisso di un nuovo enciclopedismo dal basso (potenzialmente radicale, innovativo, egalitario; nei fatti da sottoporre al giusto setaccio imposto da una ancora alluvionale dispersività). “Leaks” indica proprio la fuoriuscita involontaria di contenuti riservati. Per la prima parola, ovviamente, l’enciclopedia telematica Wikipedia ne ha sancito la fortuna, al punto che tutti i progetti digitali, anche settoriali, che vogliano porgere informazione il più possibile esaustiva, utilizzano “Wiki” pressoché come componente fissa del proprio brand. Per la seconda, “Leaks”, e il concetto di “to leak” (far emergere, far venire fuori, rilasciare in superficie), fu decisiva la precedente rivoluzione digitale di programmi come Napster, che consentivano l’ascolto gratuito di album musicali ancora inediti. L’ultimo disco della star di turno, nei dispacci delle agenzie di stampa internazionali, “leaks online”. E si presta, così, dal chiuso del diritto d’autore della grande discografia mondiale alla circolazione capillare del fanbase.
Fatto sta che Assange riceve per quasi due anni attestazioni e benemerenze, di cui in qualche misura la Chessa dà conto, nel quadro di una rappresentazione naturale del reporter free lance che fotografa la nudità del re – altro topos della narrativa fiabesca di contenuto politico. Più fatto raccontato, rilasciato al suo inveramento concreto a lungo nascosto, che morale impastoiata. Senonché, proprio nel momento in cui l’affaire WikiLeaks sarebbe potuto essere vettore di una nuova domanda di trasparenza nell’esercizio dei pubblici poteri su scala trans-nazionale, comincia il personalissimo (e in realtà universale) calvario giudiziario internazionale di Assange. Non realizza qui alcuna utilità scandagliare il personaggio e il suo recepimento mainstream: all’epoca, non privo di spettacolarizzazioni, ombre e forse mai del tutto chiarificati scoop. Assange, preso d’entusiasmo, forse ci mette del suo e i suoi podcast via web, all’inizio degli anni Dieci, appaiono ai detrattori soltanto i salotti buoni di un pensiero di alternativa, in realtà non privo di inconfessate cointeressenze, con le interviste di Chomsky e Tariq Ali, le ospitate per Hezbollah e l’incondizionata simpatia verso ogni forma di potere aggregativo contrario all’asse anglo-americano.
A Chessa va dato indiscutibile merito di non aver in nulla ceduta a questi opposti, e straordinariamente simili, chiacchiericci. Già nel novembre 2010, vieppiù, il giornalista è accusato di stupro, molestie e coercizione illegale. La legislazione svedese consente queste incriminazioni anche per i reati avverso i consenzienti, se non protetti e non preceduti dall’ottemperanza alla richiesta di controllo medico, sulle malattie sessualmente trasmissibili. Decisamente più impegnativa l’accusa che gli giunge dalla giurisdizione statunitense, ove si nomina espressamente l’attività di spionaggio – che, in base a quali circostanze aggravanti configurata, può persino giungere alla condanna capitale. Dal 2012 al 2019, Assange diventa perciò il sequestrato di lusso presso l’Ambasciata ecuadoregna a Londra. L’Ecuador sin dalla prima ora si era offerto di fornire protezione internazionale all’attivista, anche in ragione di previe ostilità col governo americano, e la concessione dello status di rifugiato politico appare inevitabilmente la prima e più percorribile veste giuridica per quella cooperazione.
Qui chiude il prequel processuale, qui apre l’originale analisi di Sara Chessa, che parla di Assange in nome della libertà d’informazione, ma con tecnica di osservazione quasi diaristica: descrive in sostanza il diario di una discesa agli inferi, che dura almeno sette anni. Il prigioniero di lusso non esiste più: spiamo invece un uomo che soffre di panico, che è incalzato negli istmi di una libertà sempre più limitata, fino a temere accuse ignominiose mano a mano più morbose e addirittura rischi per la propria personale incolumità di vita.
Perplessità di natura normativa e processualistica erano tangibili persino nell’attribuzione dello status di rifugiato, perché tali meccanismi, pur dietro una cornice internazionale di garanzia, finiscono per concretare una esagerata interrelazione tra le maggioranze politico-governative entro cui vengono determinati e la loro maggiore caducità e fragilità, nel momento in cui quegli stessi assetti di maggioranza si modificano. È proprio ciò che è successo ad Assange a partire dal 2019, quando, in modo del tutto irrituale, il governo ecuadoregno ha ristabilito la propria decisione in direzione opposta alla precedente, facendo così perdere al giornalista australiano anche quella sempre più tenue copertura legale e tuzioristica.
La catabasi di Julian Assange raggiunge sin qui l’ultima stazione del suo calvario nella prigione Belmarsh del Regno Unito: accostata a Guantanamo, per quanto il paragone sia forzoso, è comunque tra le più note e sorvegliate carceri britanniche. Ciò non bastasse, le agenzie internazionali dei diritti umani (di natura non governativa) e le più autorevoli istituzioni inter-statali (come il Gruppo di lavoro costituito presso l’ONU in materia di detenzione arbitraria) avevano variamente censurato il trattamento procedurale e penitenziario subito dall’uomo. Volta per volta, venivano allegati i trattenimenti irregolari, la prolungata detenzione, il computo inesatto dei termini prescrizionali, le condizioni di prigionia peculiarmente restrittive, superiori a ogni indice di pericolosità anche solo potenziale dell’imputato. Ciascuno di questi aspetti meriterebbe autonoma trattazione giuridica, perché va a contraddire una copiosa giurisprudenza di garanzia che ha sempre stigmatizzato, e al peggior grado, ogni forma detentiva e preventiva di tale natura. Non solo per Assange queste cautele di natura giudiziaria non sono state attivate, ma – ciò sembra trasmetterci l’accorata riflessione di Sara Chessa – il dato intuitivo della vicenda è che Julian Assange è da tredici anni ininterrottamente sotto il bersaglio di una pena in assenza di condanna giusta, che proietta l’idea di una afflizione deliberata, intenzionale, disturbante.
In tale ottica, non è qui tanto il solo Assange a interrogarci, ma la più diffusa condizione oggettiva dei detenuti “anonimi”, di ristretti e internati di ogni risma e per ogni ragione, per cui la situazione della punitività arriva molto prima di qualsivoglia condanna, trascinandosi per anni e profondendo un complessivo quanto inumano senso di inquietudine persistente.
È altra probabilmente la peculiarità della vicenda Assange: non l’uomo solo contro le potenze del mondo (tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Svezia ed Ecuador forse soltanto le prime due integrerebbero quella a-tecnica definizione), quanto e più il reietto ufficiale nei sistemi dell’informazione di massa. L’universalizzazione delle comunicazioni, nella prospettazione teorico-giuridica di Chessa, non è stata in nulla il viatico di una nuova democrazia digitale o, almeno, ha messo in mostra gli stessi limiti della democrazia rappresentativa, nello Stato costituzionale di diritto: manipolabilità e interesse del potere a veicolare i contenuti che vengono diffusi. Secondo quale criterio di attendibilità?
Lo sforzo teoretico-costituzionale dei nostri tempi meriterebbe forse la pratica disvelativa e il cimento che Michael Walzer dedicò ai rapporti tra radicalismo politico e riforma religiosa e alle relazioni tra diritto di guerra e principio di legalità. Assange è, parafrasando le parole del filosofo statunitense della critical left, un “radical saint” che combatte “guerre giuste”? Anche in questo caso, il metodo paradigmatico dell’archeologia dei saperi potrebbe rimettere a fuoco la storia ininterrotta dei rapporti sovversivi tra la limitazione dell’arbitrio governativo e la diffusione e la conoscenza dell’informazione giuridicamente rilevante. Dall’obbligo di dire la verità della teologia cataro-valdese fino all’obbligo di dissimulazione a difesa della comunità nella cultura sciita, passando per le pratiche di autoesclusione della morale quacchera, i rapporti tra singolo e autorità hanno, tra i loro tanti presupposti, proprio quello dell’asimmetria informativa. Fino a che punto il residuo fisso di segretezza, insito nelle trattative e nei negoziati volti alla messa in opera della pratica di governo, può giustificare la mancanza di conoscenza e, in caso di violazione di quella segretezza, una penetrante opera di marginalizzazione e persecuzione?
Di sicuro, la libertà d’informazione non è un servizio incidentale al corretto svolgimento della liberal-democrazia sorta dall’elaborazione borghese e rivoluzionaria illuministica. Essa, anzi, ci si presenta contemporaneamente come necessità storica e come presupposto morale, in una molteplicità di declinazioni politologicamente percorribili. Da questo punto di vista, una omologa intuizione, stando alla teoria politica italiana, sorregge tanto la massima einaudiana del “conoscere per deliberare” quanto la rivendicazione socialista di Antonio Gramsci, per cui la verità è sempre atto rivoluzionario. Nel primo senso, la conoscenza è il presupposto per la selezione argomentativa che conduce alla decisione collettiva; nel secondo, in una dottrina filosofica che mette al centro il ribaltamento dello stato di cose presente, fare circolare il funzionamento sostanziale dei poteri reali significa metterne a nudo la capacità, l’ipocrisia, la marxiana falsa coscienza.
A questi presupposti teoretici, il pensato e non breve lavoro di Sara Chessa aggiunge una convincente carica umana, che non è orpello affettivo, ma tessuto connettivo profondo, nella battaglia per le libertà fondamentali: l’immedesimazione nell’ingiustizia patita, il racconto in diretta delle sofferenze che per mezzo di essa vengono inflitte. Come e molto più di Antigone, nella Tebe violenta, particolaristica e ghettizzante della governance globale. Tra le fumanti macerie di ogni conflitto esiziale, si alza, appena un soffio, ma potentissima nel generale frastuono, la voce del padre afflitto, del genitore sconfitto. Così l’intervista inedita a John Shipton, padre dell’attivista australiano, si eleva a ulteriore testimonianza di un caso che, dall’intimissima forma del dolore individuale, suggerisce la piena e vera universalità della posta in gioco.